 Redazione Redazione  16.02.2026 • online 1 - Codice Cineca riviste: E201613 16.02.2026 • online 1 - Codice Cineca riviste: E201613
Legge 7 marzo 2001, n. 62 - Registro della Stampa Tribunale di Messina n. 3/09 - 11 maggio 2009
Direttore scientifico Carmelo Salpietro Vicedirettore scientifico Caterina Cuppari Direttore responsabile Giuseppe Micali
RedazioneLaura Colavita Andrea Barbalace Giorgia Ceravolo Direzione-RedazioneAPIG-RIGIPc/o villa " La Bussola d'Oro"Parco delle Mimose 14, Larderia Inferiore - Messina Percorsi diagnostici-terapeutici 2021
in Pronto Soccorso Pediatrico e OBI
Rubrica News in Pediatria
Editorial BoardDaniela Concolino (Catanzaro), Salvatore Cucchiara (Roma), Gianluigi Marseglia (Pavia), Michele Miraglia Del Giudice (Napoli), Sebastiano Gangemi (Messina), Giuseppe Crisafulli (Messina), Franco Paravati (Crotone), Enza D'Auria (Milano), Claudio Pignata (Napoli), Annamaria Salpietro (Brescia), Alberto Martini (Genova), Salvatore Leonardi (Catania), Eloisa Gitto (Messina), Roberto Chimenz (Messina), Carmelo Romeo (Messina), Gabriella Di Rosa (Messina), Giuseppe Parisi (Catania), Amelia Licari (Pavia), Mariangela Tosca (Genova), Eloisa Gitto (Messina) Editor AssistantsFabrizio Comisi (Vittoria), Aldo Randazzo (Palmi), Giuseppe Zampogna (Polistena) Nino Giannitto (Messina), Monica Fusco (Messina), Francesca Aurora Meo (Messina), Antonella Gambadauro (Messina), Maria Domenica Ceravolo (Messina), Valeria Dipasquale (Messina). Giuseppe Marchese (Boario-Brescia)

|
 | Organo ufficiale di Associazione Pediatrica di Immunologia e Genetica
Rivista Italiana di Genetica e Immunologia Pediatrica - Italian Journal of Genetic and Pediatric Immunology |
Stampa La pagina di stampa crea anche un file immagine
Editorial Giuseppe Micali
Benvenuti nel futuro! Leggi il Quotidiano Normanno.com del 30.11.2014. Nel 2014 era follia... dopo venti anni è divenuta pazzia d'amore verso la scienza? 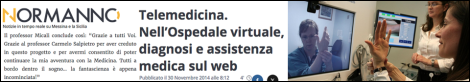 Oggi, una rivoluzionaria e semplice metodologia per redigere questa rivista è già attiva. Si sviluppa con un nuovo sistema di struttura delle pagine web: articoli intelligenti che si autoproteggono. La cella per l'inserimento dei testi si disabilita anche nel caso di una seconda immissione, modifica o correzione da parte dei redattori. Infine, un semplice comando con il telefonino, da qualsiasi parte del mondo, abilita o interrompe il sistema d'accesso. Secondo le previsioni di Gartner inc, una multinazionale che si occupa di consulenza strategica, ricerca di mercato e analisi nel campo della tecnologia dell'informazione, si smetterà di usare le password entro il 2025. Siamo ancora in viaggio per raggiungere l'irragiungibile con la forza per essere ancora utili, abbiamo superato i (sette milioni di lettori)
Un doveroso e affettuoso ringraziamento al professor Carmelo Salpietro per avermi consentito di poter continuare la mia fantastica avventura con la Medicina. Benvenuti nel futuro presente!
Chiudi
|
Caterina Cuppari1, Carmelo Salpietro2, Gianluigi Marseglia3, Annamaria Salpietro4, Federico Schettini5, Domenico Minasi6, Michele Miraglia Del Giudice7, Mariangela Tosca8, Giorgio Ciprandi9
1 Vicario U.OC. Pronto Soccorso Pediatrico con O.B.I.-Policlinico Universitario Messina
2 Già Ordinario Pediatria – Università degli Studi di Messina
3 Ordinario di Pediatria -Università degli Studi Pavia
4 Dirigente medico – UOC DI Pediatria -Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia
5 Associato di Pediatria Università degli Studi di Bari
6 Direttore UOC Pediatria - Grande Ospedale Metropolitano Reggio Calabria
7 Ordinario di Pediatria Università della Campania “Luigi Vanvitelli
8 Direttore del Centro di Allergologia dell'Istituto Gaslini di Genova
9 Specialista Allergologia, Genova
Nuove opportunità terapeutiche in bambini con IRR e Atopia
Stampa La pagina di stampa crea anche un file immagine
Review Caterina Cuppari1, Carmelo Salpietro2, Gianluigi Marseglia3, Annamaria Salpietro4, Federico Schettini5, Domenico Minasi6, Michele Miraglia Del Giudice7, Mariangela Tosca8, Giorgio Ciprandi9
1 Vicario U.OC. Pronto Soccorso Pediatrico con O.B.I.-Policlinico Universitario Messina
2 Già Ordinario Pediatria – Università degli Studi di Messina
3 Ordinario di Pediatria -Università degli Studi Pavia
4 Dirigente medico – UOC DI Pediatria -Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia
5 Associato di Pediatria Università degli Studi di Bari
6 Direttore UOC Pediatria - Grande Ospedale Metropolitano Reggio Calabria
7 Ordinario di Pediatria Università della Campania “Luigi Vanvitelli
8 Direttore del Centro di Allergologia dell'Istituto Gaslini di Genova
9 Specialista Allergologia, Genova
Nuove opportunità terapeutiche in bambini con IRR e Atopia Le infezioni respiratorie costituiscono un problema sociale sia per l'impatto epidemiologico sia per l'impatto familiare e socio-economico. In particolare, la rinite infettiva acuta (comune raffreddore) è sicuramente la più frequente patologia infettiva respiratoria. Solitamente è causata da virus, in primis i Rhinovirus, ma non raramente si assiste ad una sovrapposizione batterica. Il naso è infatti la porta di ingresso dei microrganismi patogeni ed una volta attecchiti possono coinvolgere altri tratti delle vie aeree: i seni paranasali, la faringe, l'orecchio medio e/o scendere nelle vie aeree inferiori. La sintomatologia è solitamente acuta e tende a durare pochi giorni, di regola si ritiene che dopo 5 giorni l'intensità dei sintomi scemi, se invece aumenta o persiste per più di 10 giorni si deve sospettare una rinosinusite acuta. Un altro aspetto clinicamente rilevante in età pediatrica è rappresentato dallo stretto legame tra esacerbazioni di wheezing e asma ed infezioni virali. E' stato infatti confermato con l'avvento di tecniche di diagnostica molecolare, come la polymerase chain reaction (PCR), un coinvolgimento etiologico virale in circa l'80-90% degli episodi di wheezing nei bambini in età prescolare e scolare. Gli agenti patogeni più spesso identificati sono rappresentati dal virus respiratorio sinciziale (VRS) nei lattanti, e dal rinovirus umano (RV) nei bambini più grandi. Inoltre, i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia (3-6 anni) si ammalano spesso sia perché il loro sistema immunitario non è ancora pienamente maturato sia perchè il contatto con molti altri bambini favorisce la veicolazione di infezioni. Razionale dello studioAl momento non abbiamo modo di contrastare le infezioni da virus respiratori. D'altro canto il trattamento con farmaci anti-infiammatori e/o antibiotici è clinicamente poco efficace ed inopportuno anche per le note problematiche dell'antibiotico resistenza. Inoltre, non esistono studi che dimostrino la capacità di molecole in grado di ridurre l'espressione dei recettori per i virus da parte delle cellule epiteliali bronchiali e che quindi possano prevenire o rendere meno severe le infezioni da RV ed altri virus respiratori. E' quindi evidente che l'approccio terapeutico ideale sarebbe rappresentato non dall'utilizzo di sostanze come gli antigeni batterici, che amplificano lo stress immunologico dei pazienti già notevolmente sottoposti a stimolazioni antigeniche multiple, ma dalla precoce somministrazione di “integratori di documentata efficacia”, privi di effetti collaterali, ma capaci di aiutare i delicati meccanismi immunologici del bambino a prevenire le infezioni respiratorie e ridurre prontamente la sintomatologia clinica. Scopo dello studioLo scopo dello studio è stato quello di dimostrare che la supplementazione con un integratore multicomponente “di documentata efficacia” possa essere in grado di ridurre significativamente l'impatto della rinite infettiva sui sintomi respiratori e l'infiammazione sottostante. In questo contesto, l'integratore multicomponente a base di Vitamina D3, zinco, ribes nigrum e lattoferrina (Hipp Immuno) abbiamo ipotizzato che potesse avere un importante effetto di “ristoro immunologico” e quindi essere proposto quale terapia add-on nelle IRR del bambino e nei soggetti co FAMP (Flogosi Allergica Minima Persistente). In particolare, i vari componenti esercitano, come ampiamente documentato, rilevanti attività benefiche nei soggetti con IRR. La vitamina D3 è un ormone pleiotropico che svolge una rilevante immunomodulazione, in quanto è in grado di ripristinare una fisiologica risposta tolerogenica e di tipo 1, riequilibrando così la polarizzazione di tipo 2. Inoltre, esercita una spiccata attività anti-infiammatoria, e soprattutto antimicrobica grazie alla produzione di sostanze battericide (catelicidina e beta-defensine), (fig1).  Lo zinco è un elemento che notoriamente esercita interessanti attività sul sistema immunitario, in quanto è indispensabile per
la replicazione e maturazione delle cellule immunocompetenti. Inoltre, esplica
anche attività anti-ossidanti ed anti-infiammatorie, (fig.2)  L’estratto di ribes nigrum L’estratto di ribes nigrum contiene numerosi principi attivi, tra cui flavonoidi edantocianosine, che esercitanobenefiche attività antivirali ed antibatteriche, anti-infiammatorie,muco-attive e vaso-protettive, (fig.3). In particolare la documentata attività antiinfiammatoria, per certi aspetti similcortisonica, potrebbe avere un naturale beneficio nel ridurre l’infiammazione acuta e, ancora, nel contrastare la flogosi allergica minima persistente” dei soggetti allergici.  Infine, la lattoferrina è una emo-proteina pleiotropicha, che esercita, tra le varie funzioni, un’importante attività immunostimolante, anti-infiammatoria ed anti-ossidante. E’ da rimarcare che la concentrazione di lattoferrina nel latte materno umano è 10-100 volte superiore a quella presente nei latti di altri mammiferi. Questa evidenza giustifica la sua notevole importanza nella maturazione del sistema immunitario(fig.4). 
Pertanto, tutti queste evidenze, cliniche e sperimentali, confermano e sottolineano la sua potenziale attività anti-infettiva.
OBIETTIVI DELLO STUDIO
Obiettivo primario
Dimostrazione del beneficio clinico di un integratore multicomponente, a base di Ribes nigrum, zinco, lattoferrina e vitamina D, in bambini con frequenti IR nel ridurre il loro numero e durata.
Obiettivi secondari
Dimostrazione della riduzione dell’intensità dei sintomi.
Dimostrazione della riduzione del consumo di antibiotici ed antipiretici.
Parametri
Numero infezioni respiratorie
Durata in giorni delle infezioni respiratorie
VAS segmento da 0 a 10 cm (0=nessun sintomo; 10= sintomi intensissimi)
Numero di giorni con terapia antibiotica
Numero di giorni con terapia antipiretica
Pazienti e Metodi
Sono stati selezionati 135 bambini (età > 3 e 12 anni) con una storia di frequenti infezioni respiratorie (tab.1). Di questi bambini 72 non erano atopici, mentre 63 erano atopici.
La metà dei pazienti reclutati veniva trattata con la supplementazione con l’integratore multicomponente (una bustine/die). L’altra metà di bambini ed adolescenti veniva considerata come gruppo controllo.
Tutti i bambini erano trattati all’occorrenza in caso di infezione respiratoria.
Il trattamento con il prodotto in valutazione durava 60 giorni.
Durante lo studio il Medico sperimentatore sottoponeva i pazienti partecipanti a 3 visite (T1 prima visita e avvio terapia, T2 dopo 30 giorni, T3 dopo altri 60 giorni), nell’ambito delle quali procedeva alla valutazione ed alla registrazione di parametri clinici.
Caratteristiche dei 135 pazienti reclutati.
Risultati
Come si evince dalla figura 5, a T2 (dopo 30 giorni dall’avvio della terapia), non abbiamo riscontrato una differenza significativa riguardo al numero delle infezioni, la durata dei giorni, il numero dei giorni di terapia antibiotica e/o antipiretica, tra i pazienti con IRR trattati e non.
A T3 (dopo 60 giorni di trattamento) invece emerge una significativa riduzione del numero delle infezioni, della durata dei giorni, della gravità della sintomatologia e del numero di giorni di terapia antibiotica ed antipiretica nei pazienti con IRR trattati rispetto a quelli non trattati come illustrato nella fig.6.
Nell’ambito dei pazienti con IRR non allergici, è emersa a T3, dopo 60 giorni di terapia, una significativa riduzione della gravità dei sintomi e della durata dei giorni nei pazienti trattati rispetto ai non trattati (fig.7).
Inoltre, sempre a T3 come dimostrato nella fig.8 è stata documentata una significativa riduzione dei giorni di trattamento con terapia antibiotica e antipiretica nei pazienti trattati rispetto ai pazienti non trattati.
Per i pazienti allergici con IRR è emerso già a T2 una significativa riduzione della gravità della sintomatologia, mentre a T3 si assiste ad una significativa riduzione della durata dei giorni, della terapia antibiotica ed antipiretica (fig. 9 e 10).
Abbiamo inoltre voluto valutare i possibili benefici offerti da questo integratore multicomponente in bambini ed adolescenti con rinite allergica (RA).
Obiettivo primario
Dimostrazione del beneficio clinico di questo integratore in bambini ed adolescenti nel ridurre l’intensità della sintomatologia della rinite allergica nel periodo di trattamento, valutata mediante visual analog scale (VAS), come trattamento Add-on rispetto al trattamento standard of care (anti-H1 al bisogno).
Obiettivi secondari
Dimostrazione della riduzione del consumo sintomatico di antistaminici.
Parametri
VAS segmento da 0 a 10 cm (0=nessun sintomo; 10= sintomi intensissimi)
Numero di giorni con terapia antistaminica
Pazienti e Metodi
Sono stati selezionati bambini (età > 6 e 18 anni) con una diagnosi di rinite allergica (tab.2).
La metà dei pazienti reclutati veniva trattata con la supplementazione con l’integratore multicomponente (una bustine/die). L’altrà metà di bambini ed adolescenti veniva considerata come gruppo controllo.
L’antistaminico era preso al bisogno, cioè quando l’intensità dei sintomi veniva valutata fastidiosa/intensa.
Il trattamento con il prodotto in valutazione durava 30 giorni, seguito da un follow-up di 30 giorni.
Durante lo studio il Medico sperimentatore sottoponeva i pazienti partecipanti a 3 visite (T1 prima visita e avvio terapia, T2 dopo 30 giorni, T3 dopo altri 30 giorni), nell’ambito delle quali procedeva alla valutazione ed alla registrazione di parametri clinici.

Come dimostrato nella fig.11, a T3 (dopo 60 giorni di terapia), si assiste ad una significativa riduzione dei giorni di assunzione di antistaminici nei pazienti trattati rispetto al gruppo controllo non trattato. E’ da evidenziare altresì il gradimento dei genitori che hanno aderito con entusiasmo allo studio poiché il trattamento era a base di “sostanze naturali”

Conclusioni
Questo studio dimostra che la supplementazione con un integratore multicomponente a base di Vitamina D3, zinco, ribes nigrum e lattoferrina (Hipp Immuno) può essere in grado di ridurre significativamente l’uso sia di antibiotici che di antipiretici nella gestione delle IRR. Inoltre dimostra la sua efficacia sia sulla riduzione della gravità dei sintomi che della durata. Tali effetti sono più significativi nei pazienti con atopia. Nei pazienti con rinite allergica questo integratore è in grado di ridurre significativamente i giorni di trattamento con antistaminici.
In questo contesto, l’integratore multicomponente esplicherebbe un importante effetto di “ristoro immunologico” e quindi essere proposto quale terapia add-on nelle IRR del bambino sia atopico che non. Come si evince dai risultati, ulteriormente confermati da una più ampia casistica in corso di elaborazione, il preparato multicomponente esplica un ruolo positivo nella prevenzione delle IRR e un valido aiuto anche durante i processi infettivi acuti delle prime vie aeree. Inoltre per la peculiare ed efficace sinergia dei componenti e, verosimilmente, per la presenza del ribes nigrum, favorisce la riduzione della flogosi allergica minima persistente con l’attenuazione di quel percorso allergico sotterraneo che porta gradatamente alla estrinsecazione clinica delle malattie allergiche.
Bibliografia
• Recurrent upper respiratory tract infections in early childhood: a newly defined clinical condition. A. Corsello, G. P. Milani, M. Picca et al. Italian Journal of Pediatrics volume 50, Article number: 30 (2024)
• Leading reasons for antibiotic prescriptions in pediatric respiratory infections: influence of fever in a primary care setting. Picca M, Carrozzo R, Milani GP, Corsello A, Macchi M, Buzzetti R, et al. Ital J Pediatr. 2023;49:131
• The child with recurrent respiratory infections: normal or not? de Martino M, Ballotti S. Pediatr Allergy Immunol off Publ Eur Soc Pediatr Allergy Immunol. 2007;18(Suppl 18):13-8
• Atopic children are more susceptible to viral respiratory infection at the age of 2-5 years old. S.Stamataki , A. Georgountzou , N.G Papadopoulos et al. Allergy Asthma Proc. 2023 Jan 28;44(1):64-70.
• Atopic children are more susceptible to viral respiratory infection at the age of 2-5 years old . Sofia Stamataki et al. Allergy and Asthma Proceedings January 2023, Vol. 44, No. 1
• A review of the critical role of vitamin D axis on the immunesystem. Gholamreza Daryabor , Nasser Gholijani , Fatemeh Rezaei Kahmini et al. Experimental and Molecular Pathology. Volumes 132-133, August 2023
• A review of the biological activities of lactoferrin: mechanisms and potential applications. Ruiyao Hong, Aijun Xie, Chengxi Jiang et al. Food Funct., 2024,15, 11811-11833
• Lactoferrin, a multi-functional glycoprotein: Active therapeutic, drug nanocarrier & targeting ligand. Ahmed O. Elzoghby et al. Biomaterials Volume 263, December 2020
• Biological activities, therapeutic potential, and pharmacological aspects of blackcurrants (Ribes nigrum L) A comprehensive review. Afaf Ejaz, Sadaf Waliat, Muhammad Afzaal et al. Food Sci Nutr. 2023;11:5799-5817.
• Anti-viral and anti-bacterial activities of an extract of blackcurrants (Ribes nigrum L.).
• Kazufumi Ikuta, Koichi Hashimoto, Hisatoshi Kaneko et al. Microbiol Immunol 2012; 56: 805-809
• Blackcurrant (Ribes nigrum) Extract Exerts an Anti-Inflammatory Action by Modulating Macrophage Phenotypes. Yoojin Lee, Ji-Young Lee et al. Nutrients 2019 Apr 28;11(5):975.
• The nutritional roles of zinc for immune system and COVID-19 patients. Di Jin et al. Front. Nutr. , 19 April 2024
• A multicomponent food supplement in managing children with recurrent respiratory infections: a primary care exsperience.C.Cuppari, C.Salpietro, G.L.Marseglia, A.Salpietro, F.Schettini, D-Minasi, M.Miraglia Del Giudice, M.Tosca, G.Ciprandi Minerva pediatr. (in press)
• A multicomponent food supplement in managing children with allergic rhinitis: a primary care exsperience. C.Cuppari, C.Salpietro, G.L.Marseglia, A.Salpietro, F.Schettini, D-Minasi, M.Miraglia Del Giudice, M.Tosca, G.Ciprandi Minerva pediatr. (in press)
Chiudi
|
Stampa La pagina di stampa crea anche un file immagine
Case Report A. Meo, G. Amato, K. Cardali, C. Chiarello Mr Di Bella,
Ml Mancuso, I. Polimeni, M. Romani, B. Russo, A. Betto
UOC Pediatria-Neonatologia Ospedale Fogliani, Milazzo
Su un caso di paralisi del facciale in un bambino di 7 anni Presentazione del caso
R. viene condotto alla nostra osservazione , in regime di PS ,dal padre il quale aveva notato come il volto del bambino diventasse asimmetrico quando lo stesso sorrideva. In anamnesi patologica prossima un episodio infettivo caratterizzato da febbre, otalgia e cefalea per cui aveva avviato da 3 giorni terapia antibiotica con amoxicillina per os sotto indicazione della Curante. Nulla da segnalare all'anamnesi patologica remota e all'anamnesi familiare. Alla visita R. si presentava in buone condizioni generali ed apiretico. All'esame obiettivo si evidenziava un'asimmetria oculare: l'occhio dx si chiudeva solo parzialmente. Alla valutazione dinamica impossibilità nei movimenti dell'orbicolare dell'occhio dx. L'emirima buccale dx appariva più bassa della controlaterale e vi era una marcata asimmetria orale nella valutazione dinamica. Notavamo inoltre un lieve appiattimento del solco naso-genieno. La palpazione della regione mastoidea dx era percepita come dolorosa. All'otoscopia constatavamo un'iperemia del CUE bilat, no vescicole erpetiche. R. riferiva ipoacusia bilaterale.
Il quadro clinico era suggestivo di paralisi del facciale periferica.
Come tutti i nuclei motori del sistema nervoso centrale, anche quello del VII cranico viene innervato dalla corteccia cerebrale, al fine di esplicare la motilità volontaria (innervazione sopranucleare). Il nucleo del faciale ha la caratteristica peculiare di essere innervato nella sua parte superiore da afferenze dalla corteccia motoria omo e controlaterale, mentre nella sua parte inferiore viene innervato solo dalla corteccia motoria omolaterale. Questa caratteristica è molto importante ai fini della diagnosi differenziale tra lesione centrale e periferica.
Nelle paralisi centrali infatti viene coinvolta solo la parte inferiore dell'emivolto controlaterale alla lesione , nella paralisi periferica invece viene interessato tutto l'emivolto omolaterale alla lesione.
Stabilito che la paralisi è di tipo periferico, prima di ipotizzare una causa idiopatica (paralisi di Bell) , soprattutto in età evolutiva, bisogna cercare la presenza di altre concause, in particolare infezioni dell'orecchio interno e medio. Il nervo facciale essendo contenuto per un suo segmento all'interno del canale acustico interno può essere sottoposto a compressione ab estrinseco in corso di otomastoidite. Allo stesso modo deve essere esclusa la sindrome di Ramsay Hunt , seconda causa di paralisi periferica del faciale in età pediatrica, dovuta alla riattivazione del virus varicella zoster (VZV). Quest'ultima si presenta classicamente con paralisi periferica monolaterale del faciale, otalgia ed eruzione cutanea auricolare ipsilaterali , eruzioni assenti nel nostro caso.
Nel sospetto di una paralisi otogena del nervo facciale sottoponevamo R. ai seguenti esami/consulenze:
-Emocromo Gb : 14.000/mmc N 73.5% L 18,4 % Hb 13,2 gr PLT 663.000/mmc PCR 126 (Nx25)
-Consulenza ORL: “paresi facciale destra con rialzo febbrile, cefalea, tremori, otite bilaterale. Prima di prescrivere terapia si consiglia valutazione neurologica”
-Consulenza Neurologica: “Paralisi periferica del VII nc di destra , iperirresia. Si consiglia RMN encefalo + angio RMN distretto intracranico urgente. Valutazione specialistica di pertinenza.”
-Consulenza Neuropsichiatria Infantile: “Paralisi periferica del VII nervo cranico. Si indica esecuzione di Tc encefalo.”
-Tc cranio: “diffuso opacamento dei seni mascellari ,dei seni frontali , del seno sferoidale , delle cellule etmoidali e delle cellule mastoidee bilateralmente”
R. veniva quindi ricoverato presso il nostro reparto di pediatria e trattato con antibiotico terapia a largo spettro (ceftriaxone 100mg/kg) ; terapia antiedemigena (idrocortisone 4mg/kg) , omeprazolo 20 mg/die , complesso polivitaminico del gruppo B e per la prevenzione della cheratite lacrime artificiali , pomata oftalmica con vitamina A ed occlusione palpebrale notturna.
Nelle prime 24h di ricovero eseguivamo inoltre RMN encefalo , esame necessario per la diagnosi differenziale con danno cerebrovascolari da danno arterioso/venoso.
Alla RMN encefalo “Si rileva la presenza di un specifico , millimetrico focolaio iperintenso , disposto nella sostanza bianca sottocorticale parietale destra , riferibile in prima ipotesi a gliosi da ischemia parcellare.” Decidiamo quindi di proseguire la terapia già avviata e rivalutare tale reperto a distanza.
Durante il ricovero , durato 12 giorni, eseguivamo uno stretto monitoraggio clinico e laboratoristico con emocromo ed indici di flogosi.
Eseguivamo inoltre le seguenti sierologie
-sierologie per Borrelia, HSV 1 e 2, Varicella zoster, CMV, Adenovirus, Coxsackievirus (virus neurotropi) negative
ed i seguenti esami
-Esame audiometrico tonale : documentata ipoacusia bilaterale
-Timpanometria: Timpanogramma di tipo B
- Visita ORL con successiva timpanocentesi bilaterale ed esame colture tampone auricolari (negativi)
-Consulenza oftalmologia: lagoftalmo , si da indicazione ad unguento oftalmico prima di dormire
Durante il ricovero assistevamo ad un lieve miglioramento dell'emiparesi facciale. Dimettevamo quindi R. con indicazione a proseguire follow-up clinico e radiologico presso il nostro ambulatorio. Esami di laboratorio pre dimissioni nella norma.
Il follow-up radiologico è stato effettuato tramite RMN contrastografica.
Al controllo ad 1 mese la RMN encefalo documentava: notevolmente ridotto l'ispessimento della mucosa parietale dei seni paranasali, permanendo in minima parte a livello del seno mascellare di sinistra. Ridotta altresì la tumefazione dei tessuti molli della volta/parete posteriore del rinofaringe. Per converso appare immodificata la quota di materiale iperintenso nelle sequenze a TR lungo posta nel contesto delle celle mastoidee bilateralmente. Sempre apprezzabile nelle scansioni a TR lungo la presenza di aspecifico e millimetrico focolaio iperintenso, disposto nella sostanza bianca sottocorticale parietale destra, riferibile in prima ipotesi a gliosi da ischemia parcellare. Con i limiti dati dagli artefatti da movimento, nella sequenza PCA venosa si documenta sostanziale pervietà dei principali rami e seni venosi intracranici, fatta eccezione per la porzione distale del seno trasverso di destra e del seno sigmoideo omolaterale, che appaiono filiformi, e in cui a tale livello si rileva iperintensità FLAIR (trombosi venosa? ipoplasia dei relativi seni venosi?).Al controllo a 3 mesi ottenevamo il recupero neurologico completo e la normalizzazione dell'esame audiometrico.
RMN a 3 MESI : Al controllo attuale appare risolto l'ispessimento della mucosa parietale dei seni paranasali e notevolmente ridotta la quota di materiale iperintenso nelle sequenze a TR lungo posta nel contesto delle celle mastoidee bilateralmente, che permane in minima parte a destra. Sempre apprezzabile nelle scansioni a TR lungo la presenza di aspecifico e millimetrico focolaio iperintenso, disposto nella sostanza bianca sottocorticale parietale destra, riferibile in prima ipotesi a gliosi da ischemia parcellare. Nella sequenza PCA venosa si documenta sostanziale pervietà dei principali rami e seni venosi intracranici. Il seno sigmoideo e trasverso di destra appaiono, seppur maggiormente rappresentati rispetto ai controlli RM precedenti, sempre di calibro ridotto rispetto ai controlaterali, come da possibile ipoplasia; meno verosimile, ma non del tutto escludibile l' ipotesi di esiti/complicanza della pregressa otomastoidite.
Sospendevamo quindi il follow-up.
Conclusioni
Le paralisi facciali sono un motivo di visita ben noto a neurologi e a ORL. La conoscenza del decorso anatomico e della fisiologia del nervo faciale è fondamentale per spiegare la diversità dei quadri osservati. La diagnosi di paralisi facciale a frigore deve restare una diagnosi di esclusione, dopo la ricerca di un'eziologia infettiva, vascolare o tumorale. La causa vascolare va sempre esclusa tramite RMN. Il trattamento dipende dal tipo di paralisi constatato e dalla sua eziologia e si limita, a volte, a misure sintomatiche, che non bisogna trascurare. La prognosi è variabile, andando dal recupero completo alla persistenza di postumi importanti.
Chiudi
|
Stampa La pagina di stampa crea anche un file immagine
Abstract M.F. Astorino1, R. Civa2, C. Di Bella2, M.A. La Rosa2, M. Cutrupi2, B. Piraino2, E. Esposito1,2,
S. Briuglia1,2
1. Università degli Studi di Messina
2.
U.O.S.D. Genetica e Farmacogenetica Policlinico Universitario di Messina
L’impronta del percorso di consulenza genetica nelle coppie infertil in PMA L’infertilità è una condizione complessa che colpisce circa il 15% delle coppie italiane in età fertile, con una percentuale significativa di casi ad eziologia sconosciuta. Questo studio si propone di analizzare i risultati dei test genetici raccomandati dalla normativa italiana, condotti su 169 coppie infertili seguite presso il Policlinico Universitario "G. Martino" di Messina nel 2024, nell’ambito del percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA). Sono state identificate anomalie genetiche significative, incluse traslocazioni cromosomiche, inversioni del cromosoma Y, mosaicismi del cariotipo e mutazioni associate a condizioni genetiche quali fibrosi cistica e talassemie. L'analisi sottolinea il ruolo cruciale della diagnosi genetica precoce nel migliorare gli esiti clinici della PMA e nel definire strategie preventive per una gestione personalizzata delle coppie infertili.
Introduzione
L'infertilità è definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come l'assenza di concepimento dopo 12/24 mesi di rapporti sessuali regolari non protetti. In Italia, questa condizione interessa circa il 15% delle coppie (1 su 6) in età fertile (Sanità). Nel 25-30%d dei casi non è nota l’eziologia dell’infertilità di coppia che resta una condizione che impatta gravemente sulla qualità della vita e sul benessere psicologico dei partner (Umana). La normativa italiana che regola l'accesso alla PMA è contenuta nella Legge n. 40 del 19 febbraio 2004, che stabilisce i criteri per la diagnosi e il trattamento dell'infertilità, inclusa la raccomandazione ad eseguire specifici test genetici nel percorso diagnostico delle coppie infertili. L’integrazione dei test genetici nell’approccio alla PMA offre nuove prospettive per aumentare il successo procreativo stabilendo la metodica di PMA più opportuna e diagnosticare preventivamente la presenza di alterazioni genetiche causative dell’infertilità di coppia (Umana).
Gli accertamenti di screening previsti tendono, in accordo con la normativa italiana, ad assimilare la gravidanza da concepimento assistito alla gravidanza spontanea e a ridurre e semplificare gli esami richiesti in sede preconcezionale. Pertanto, alle coppie è chiesto di sottoporsi ad una serie di esami genetici per la valutazione del rischio riproduttivo, volti a identificare eventuali anomalie genetiche che possano influenzare la fertilità o rappresentare un rischio per la salute della prole.
Tra i test raccomandati (Umana):
•Screening per la fibrosi cistica analisi del gene CFTR: La fibrosi cistica è una delle malattie genetiche autosomiche recessive più comuni nella popolazione italiana. La normativa richiede l'identificazione dei portatori per minimizzare il rischio di trasmissione ai figli. L’analisi si rivolge principalmente alla partner femminile ma considerata la correlazione tra la presenza della mutazione F508Del e condizioni di azoospermia, oligoastenoteratozoospermia, il test viene esteso anche alla popolazione maschile.
•Screening trombofilico di I livello (della partner femminile) esteso ad un II livello sulla base dell’anamnesi/storia familiare: La trombofilia ereditaria è una patologia genetica che comporta un aumento del rischio di trombosi venose nel croso della gestazione.
•Analisi della sindrome dell'X fragile (della partner femminile): Raccomandata per valutare il rischio di trasmissione di questa condizione, che può essere associata a insufficienza ovarica precoce nella donna o a disabilità intellettiva nei figli.
•Analisi delle microdelezioni del cromosoma Y: Esame mirato alla rilevazione di microdelezioni associate all'infertilità maschile, utile per valutare la spermatogenesi.
•Analisi del cariotipo (di entrambi i partner): Obbligatoria per individuare anomalie cromosomiche, come traslocazioni bilanciate o aneuploidie, che potrebbero interferire con il successo della PMA o causare aborti ricorrenti.
•Test per le talassemie (di entrambi i partner): Particolarmente rilevante nelle regioni italiane con alta prevalenza di portatori di beta-talassemia, per identificare coppie a rischio di generare figli affetti.
Scopo del lavoro
Il presente lavoro si pone l’obiettivo di proporre una analisi statistica dei dati raccolti da Gennaio a Dicembre 2024 presso il laboratorio di Genetica dell’U.O.S.D. di Genetica e Farmacogenetica del Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina riguardanti le coppie infertili seguite in consulenza genetica nel percorso di PMA per infertilità di coppia. In particolare, verranno esaminati i risultati dei test genetici previsti e raccomandati secondo normativa italiana al fine di valutare la presenza di specifiche anomalie genetiche nella popolazione esaminata; evidenziare l’importanza della diagnosi genetica precoce nel miglioramento degli esiti clinici dei trattamenti di PMA; contribuire a delineare strategie preventive per una gestione più efficace delle coppie infertili.
Caso studio
Nell’anno solare 2024 sono giunti in consulenza genetica con indicazione di infertilità all’interno del percorso di PMA, 169 coppie. Di queste sono risultate positive ai test di screening 12 coppie di cui si esaminano di seguito i singoli casi e si riassumono nel Grafico 1 le anomalie riscontrate tra partner maschili e femminili.
Cariotipo
L’analisi del cariotipo è stata condotta mediante tecnica di Bandeggio GTG eseguita su linfociti estratti da sangue periferico. Per ogni campione si analizza una media di 20 cellule con un livello di risoluzione medio pari a 400.
Caso 1. Un soggetto di sesso maschile mostra un cariotipo 45,XY rob(14;22)(14q;22q). Il soggetto è pertanto portatore di una traslocazione Robertsoniana.
Caso 2. Due soggetti di sesso maschile mostrano un cariotipo 46,X, inv(Y)(p11;q11). I soggetti sono pertanto portatori di una inversione che interessa le regioni del braccio corto e del braccio lungo del cromosoma Y.
Caso 3. Un soggetto di sesso femminile mostra un cariotipo a mosaico 45,X/46,XX. Per questa diagnosi sono state analizzate 100 metafasi di cui il 25% è risultato 45,X mentre il restante 75% è risultato 46,XX.
Screening fibrosi cistica
L’analisi della mutazione del gene CFTR per la determinazione del portatore della fibrosi cistica è stata condotta mediante tecnica del reverse dotblot e analisi della sequenza.
Caso1. Un soggetto maschile è risultato portatore della variante N1303K in eterozigosi c.[3909C>G];[=]p.[(Asn1303Lys)]. La variante N1303K si associa a mutazione missenso, con sostituzione di un residuo di asparagina con un residuo di lisina in posizione 1303 causando difetti di maturazione della proteina che non può essere trasportata nel sito funzionale a livello della membrana apicale. Questa mutazione ha una frequenza nella popolazione pari a circa l’1% e l’associazione con l’infertilità è stimata a circa il 10% nelle cause di azoospermia ostruttiva congenita da presenza di mutazione nel gene CFTR (Hojati et al., 2012).
Caso2. Un soggetto maschile è risultato portatore in eterozigosi della mutazione F508del c.[1521_1523delCTT];[=]p[phe508del];[=]. Per questo soggetto è consigliata la consulenza genetica di coppia in quanto la probabilità di avere un figlio affetto da fibrosi cistica è pari a 1:4.
Caso3. Un soggetto maschile e due soggetti femminili sono risultato portatori in eterozigosi della variante IVS8 (5T/11TG)(7T/12TG). Per i soggetti femminili questo determina lo stato di portatrici sane della variante del gene CFTR associato a fibrosi cistica.
Microdelezione del cromosoma Y
L’analisi della presenza di microdelezione sul cromosoma Y è stata condotta mediante QF-PCR e analisi di elettroforesi capillare.
Caso1. Un soggetto maschile è risultato portato della delezione (gr/gr) nella regione AZFc del cromosoma Y.
Screening delle talassemie e dei geni globinici
L’analisi dello stato di portatore di talassemia è eseguita come screening mediante la cromatografia liquida ad alta prestazione. Questo test consente di individuare e di quantificare le varianti fisiologiche dell’emoglobina e le emoglobine atipiche. Le principali varianti fisiologiche dell’emoglobina A1 (Hb-A1) sono l’emoglobina fetale (Hb-F) e l’emoglobina A2 (Hb-A2). In caso di positività del test si procede all’approfondimento dei geni globinici mediante analisi di reverse dotblot e conferma con la sequenza.
Caso1. Un soggetto maschile con diagnosi di δ-talassemia, eterozigote per HBD c.82G→T (p.Ala28Ser)(δcd 27. GCC→TCC). Il soggetto presentava un emocromo caratterizzato da lieve microcitosi, un aumento dell’HbA2 e un significativo aumento dell’HbF.
Caso2. Un soggetto femminile con diagnosi di β-talassemia, eterozigote per IVS1-110 (G>A). Il soggetto presentava un emocromo caratterizzato da più bassi livelli di emoglobina, volume corpuscolare medio >50 <70 e più alto livello di HbF.
Caso3. Un soggetto femminile con diagnosi di β-talassemia, eterozigote per -101(C->T)/Codon39(C->T). Il soggetto presentava un emocromo caratterizzato da più bassi livelli di emoglobina, volume corpuscolare medio >50 <70 e più alto livello di HbF.
Caso4. Un soggetto femminile con diagnosi di α-talassemia, eterozigote per -α(3.7)/αα.
Discussione
Le coppie giunte in consulenza presso il nostro laboratorio e risultate positive alle analisi genetiche a cui si sono sottoposte, correlano con l’indicazione all’esame di infertilità. Nell’indagine del cariotipo la presenza di traslocazioni Robertsoniane si associa a molte manifestazioni cliniche, tra cui l’infertilità maschile e gli aborti ricorrenti. Studi confermano che una insolita immaturità nella struttura degli spermatozoi si associa alla traslocazione tra i cromosomi 14 e 22. Questa anomalia cromosomica sembra possa influenzare negativamente il processo di spermatogenesi con un effetto intercromosomico sulla segregazione nel corso della meiosi (Baccetti et al., 2002). Nel caso 1, soggetto maschile portatore della traslocazione Robertsoniana, l’esito negativo degli esami di screening nella partner femminile, porterebbero a supporre e far ricadere sul maschio la causa della infertilità di coppia.
Nel caso2, i soggetti portatori di una inversione che interessa le regioni del braccio corto e del braccio lungo del cromosoma Y potrebbero risultare causativi della infertilità di coppia in quanto l’esito degli esami di screening nelle partner femmine è negativo. Dalla letteratura si riporta che circa il 5,6% dei cariotipi anormali è 46, X, inv(Y)(q11). L’inversione del cromosoma Y può comportare la perdita dei locus genici associati allo sviluppo delle gonadi maschili, causando displasia gonadica e infertilità. L’analisi del liquido spermatico tramite uno spermiogramma permetterebbe di evidenziare oligospermia, astenospermia e azoospermia dovute ad alterazioni nel corso della meiosi con incapacità di formazione dei gameti (Fu et al., 2023).
Il caso3 è un soggetto femminile con cariotipo a mosaico, riportato in letteratura in circa il 25% dei casi, si associa a una forma più lieve di Sindrome di Turner (Snyder et al., 2021). Fino ad oggi, in letteratura sono pochi i casi discussi perché non è stata eseguita una valutazione sistematica delle pazienti con vari livelli di mosaicismo 45,X/46,XX. Tuttavia, è comune il riscontro di storia di infertilità primaria nei soggetti femmina analizzati (Moore et al., 2008). Le analisi di screening sul partner maschile risultano negative pertanto sembrerebbe che l’anomalia del cariotipo del soggetto femminile possa essere la causa dell’infertilità di questa coppia.
Per quanto riguarda lo screening di portatore della mutazione del gene che determina la fibrosi cistica, tutti i casi analizzati riconducono, con frequenze diverse nella popolazione, a condizioni che si associano ad infertilità è stimata a circa il 10% nelle cause di azoospermia ostruttiva congenita da presenza di mutazione nel gene CFTR (Hojati et al., 2012) che determina aplasia congenita unilaterale o bilaterale dei dotti deferenti (CBAVD) (Asadi et al., 2019).
La microdelezione riscontrata nel cromosoma Y del soggetto maschile è una delezione parziale della regione AZFc, considerata un fattore di rischio per il fallimento della spermatogenesi. Questa delezione rimuove circa metà della regione AZFc, compresi alcuni geni ed unità trascrizionali testicolo specifici, e può essere trasmessa alla progenie maschile. Le delezioni “gr/gr”, invece, si riscontrano più frequentemente nei pazienti rispetto al gruppo di soggetti normozoospermici (4,6% versus 0,5%; p<0,024); questo permette di ipotizzare un effetto negativo di questo polimorfismo sull’efficienza della spermatogenesi. Il valore di rischio relativo (O.R.=8,89), infatti, indica che queste delezioni possono essere considerate un fattore di rischio per l’alterazione della spermatogenesi ed in particolare per l’oligozoospermia severa (riproduzione).
Non molto si può invece dire per quanto riguarda la correlazione tra talassemia e infertilità. Considerata però la trasmissione a carattere autosomico recessivo delle talassemie è bene che le coppie in cui uno dei partner sia risultato positivo al test, siano seguite in sede di consulenza genetica e in caso di percorso di PMA.
Conclusioni
Questo lavoro mette in evidenza come l’integrazione dei test genetici nel percorso di PMA consenta di identificare anomalie genetiche specifiche che possono compromettere la fertilità e influenzare negativamente gli esiti riproduttivi. I dati raccolti dimostrano l’importanza della diagnosi precoce nel favorire una gestione personalizzata delle coppie infertili, contribuendo non solo ad aumentare il tasso di successo dei trattamenti, ma anche a ridurre i rischi per la prole. La stratificazione dei pazienti sulla base delle anomalie riscontrate potrebbe rappresentare una strategia vincente per ottimizzare i protocolli di PMA e per fornire un supporto più mirato alle coppie. Infine, si sottolinea l'importanza di un approccio multidisciplinare e di ulteriori studi per approfondire l’impatto delle anomalie genetiche sui percorsi di infertilità.
Chiudi
|
Stampa La pagina di stampa crea anche un file immagine
Review Italo Farnetani
Professore Ordinario di Pediatria Università Ludes - United Campus of Malta
Leishmaniosi: Gabbi, ordinario di Messina, sconfisse il Premio Nobel francese Introduzione
La storia della leishmaniosi offre, tra gli altri, due aspetti interessanti. Il primo dimostra il contributo fondamentale dei ricercatori siciliani che furono determinanti nello studio della malattia, in cui fu capofila la scuola medica messinese diretta dall'ordinario di clinica medica, Umberto Gabbi.
Il secondo aspetto è valido a livello della medicina mondiale perché è un modello per impostare correttamente il rapporto fra scoperte scientifiche, nuove tecnologie, attualmente anche l' intelligenza artificiale, e la clinica che coinvolge il ragionamento clinico e il rapporto medico-paziente.
Anticipando le conclusioni che verranno tratte dal testo successivo, che ricostruisce una parte del percorso storico dello studio della malattia, si ha la conferma della validità dell'insegnamento di Ippocrate, in particolare che che la medicina vada fatta al letto del malato senza mai dimenticare il rapporto e l'osservazione del paziente. Anche oggi dobbiamo ribadire l'importanza del pensiero di Ippocrate, promuovendo i contenuti e gli insegnamenti. Questo processo si chiama neoippocratismo e si è presentato ciclicamente nella storia: nel Seicento, dopo Galileo, nella seconda metà dell' Ottocento, dopo gli avanzamenti soprattutto nel campo della microbiologia e lo dobbiamo rinnovare ancora oggi.
E se la storia della leishmaniosi è una punta di orgoglio per il mondo accademico messinese e della Sicilia intera è ancora più importante come richiamo al neoippocratismo. Ecco perché.
I francesi da Tunisi: due parassiti, due malattie
Nel 1908 Charles Jules Henri Nicolle (Rouen,Francia, 1866-Tunisi, 1936), futuro Premio Nobel per la medicina, fece a Tunisi, ove dirigeva il locale Istituto Pasteur, una fondamentale scoperta perché dimostrò che la leishmaniosi, presente nel Mediterraneo, era provocata da un parassita, esattamente un protozoo, che denominò leishmania infantum. riuscendo, per primo a coltivarlo, a dimostrare che il cane era il serbatoio, riuscendo anche a trasmettere la malattia dall'uomo al cane.
L'entusiasmo di Nicolle per la scoperta di un nuovo parassita, la Leishmania infantum, lo portò ad affermare che era presente solo nell'area del bacino del Mediterraneo ove era l'unico parassita responsabile del kala-azàr del Mediterraneo (questa forma era chiamata più spesso col sinonimo di anemia da Leishmania e oggi leishmaniosi), ma non del kala-azàr indiano che, secondo lui, era provocato esclusivamente dalla Leishmania donovani, quella descritta da Leishman nel 1904.
Nicolle, aveva accertato che l'aspetto microscopico e la risposta agli esami di laboratorio della Leishmania infantum era totalmente diversa dalle altre Leishmanie, pertanto affermò che il kala-azàr del Mediterraneo era una malattia nuova, diversa dalle altre. Negli anni successivi Nicolle portò un'ulteriore prova: la Leishmania infantum, poteva essere trasmesso al cane, mentre non era possibile con la Leishmania donovani, cioè quello indiana.
Le conclusioni di Nicolle non furono però accettate dall'intero mondo scientifico internazionale, ma divisero gli scienziati che stavamo studiando e ricercando lungo le sponde del Mediterraneo e si creò un dibattito, vivace, allora definito polemica basata su scambi di dati scientifici e differenti risultati di ricerche. Questo dibattito, che appassionò e coinvolse gli scienziati di mezzo mondo, si svolse con relazioni ai congressi e pubblicazioni contenenti le argomentazioni a sostegno delle proprie teorie e contestazioni reciproche.
Le due fazioni erano capeggiate dal futuro Premio Nobel, Charles Nicolle e da un grande scienziato italiano, Umberto Gabbi (Casteldidone, Cremona, 1860 - Figline Valdarno, Firenze, 1933), ordinario e direttore della clinica medica dell'Università di Messina, ove era giunto nel 1895 in qualità di professore ordinario di patologia speciale medica. Nel 1903 divenne direttore della clinica medica che ristrutturò e riorganizzò, inaugurandola nel 1907. Per celebrare l'evento si tenne a Messina, dal 9 al 12 giugno 1907, il terzo Congresso medico siciliano. Nel 1908 Gabbi e i suoi allievi descrissero i primi casi di leishmaniosi a Messina e successivamente in Calabria.
Gli italiani da Messina:: due parassiti, una malattia
Gabbi sosteneva che non ci fossero differenze fra kala-azàr indiano e kala-azàr mediterraneo in quanto le due malattie presentavano identici i sintomi tipici, soprattutto per l'andamento e la durata della febbre e l'ingrossamento della milza. Documentò con decisione le sue convinzioni che raccolse in numerose pubblicazioni dal titolo assolutamente eloquente: Il kala-azàr indiano e mediterraneo sono identici, pubblicato sulla rivista medica, Pathologica, (annata VI [1913-14], pp. 69-74); Il kala-azàr indiano e mediterraneo sono identici; nuove indagini sperimentali, apparso su Malaria e malattie dei paesi caldi, (annata V [1914], pp. 14-22). Tre anni più tardi, sulla stessa rivista, Malaria e malattie dei paesi caldi, Gabbi ribadì con forza le proprie argomentazioni in una pubblicazione intitolata: Sulla unità etiologica delle varie leishmaniosi, (annata VIII [1917], pp. 10-20).
Lo scontro, intellettuale e scientifico, che si consumò fra le due sponde del canale di Sicilia rappresenta un importante esempio, anche didattico, legata ai progressi della scienza e un'ulteriore dimostrazione dell'importanza della scuola ippocratica, perciò, ancora una volta, ritorna la centralità della cultura medica del Mediterraneo, inossidabile attraverso secoli e millenni.
Nonostante che il confronto avvenisse sugli argomenti scientifici più moderni e avanzati del tempo e i protagonisti fossero i migliori medici dell'epoca, ebbe ragione chi si basò sugli insegnamenti di Ippocrate.
L'errore del Premio Nobel: troppa fiducia nel laboratorio e poca clinica
Uno dei protagonisti, Charles Nicolle era già allora uno dei grandi scienziati internazionali, autore di importanti ricerche nei vari settori delle malattie infettive tanto da ricevere nel 1926 il Premio Nobel per la medicina e la fisiologia per gli studi fondamentali sul tifo petecchiale.
Nel 1908 però compì un errore, analogo a quello che si è ripetuto più volte nella storia della medicina, legato ai progressi della scienza che fanno credere di poter abbandonare tutta le acquisizioni del passato. È successo dopo Galileo e, nell'Ottocento e Novecento, come nel caso di Nicolle, dopo le grandi scoperte legate all'uso del microscopio e al successivo sviluppo della microbiologia. In quegli anni si pensava che, con la possibilità di riconoscere gli agenti infettivi e poterli esaminare in laboratorio si potesse riuscire a capire l'origine delle malattie.
Nicolle fece lo stesso errore: in base alle sue raffinate e pregevoli ricerche: scoprì un nuovo parassita, che chiamò Leishmania infantum, che era diverso dalla Leishmania donovani.
A trarlo in inganno fu la netta differente localizzazione geografica dei due parassiti, infatti aveva riscontrato la Leishmania infantum solo nell'area del bacino del Mediterraneo. Al contrario non aveva mai trovato Leishmania donovani, che era presente solo in India.
Pensò così di poter spiegare tutto: c'erano due diversi parassiti, con comportamento in laboratorio, presenti in aree geografiche diverse, lontane e ben definite.
La conferma avveniva anche dall'analisi epidemiologica: la Leishmania infantum veniva trasmessa all'uomo dal cane, in cui poteva anche essere iniettata e infettare l'animale, mentre tutto ciò era impossibile farlo con la Leishmania donovani, quella indiana
In base a tutte queste differenti caratteristiche Nicolle concluse che dovevano esserci due diverse forma morbose e così proclamò la scoperta di una nuova malattia.
L'eccessiva fiducia nelle tecnologie del momento fu la causa di un così grave errore perché Nicolle sottovalutò che i malati sia in Europa, sia in India presentavano sintomi identici, perché riteneva ormai superata la visita medica, in quanto riteneva che i progressi della medicina di laboratorio rappresentare il criterio scientifico su cui basarsi.
Per questo Nicolle voleva la conferma dagli esami di laboratorio, come ribadì nella sua relazione al Congresso di Trapani: ecco un passaggio.
Dobbiamo ora affrontare l'argomento se si debba identificare la malattia mediterranea di cui abbiamo parlato con il kala-azar indiano. A priori la domanda non sembra ammissibile, i sintomi delle due infezioni sono simili il parassita, anche se poco studiato nelle Indie sembra lo stesso (…) Noi non abbiamo personalmente alcuna prevenzione contro la possibilità di identificare le due malattie (…) Concludo dicendo che, prima di trarre una conclusione, attendo i risultati di nuovi esperimenti di cui non capisco il ritardo perché niente è più semplice che coltivare una Leishmania e di ripetere le inoculazioni del virus nel cane…
État actuel de la question du kala-azar infantile. Comunication presentée au Congres de Médicine de Trapani, Archives de l'Istitut Pasteur de Tunis, Fasc III, 1910, pp. 109-114. Testo originale in francese tradotto dall'autore
Aveva ragione Umberto Gabbi
Gabbi contestò duramente la teoria di Nicole sostenendo che, anche se i parassiti erano diversi la malattia, che era conosciuta già da tempo nel bacino del Mediterraneo, presentanva gli stessi sintomi della forma diffusa in India, pertanto si trattava di un'identica malattia, provocata da due agenti infettivi diversi, ma "parenti fra loro". Il primo ad appoggiare Gabbi fu Raimondo Feletti, direttore della clinica medica di Catania. Rapidamte le argomentazioni di Gabbi convinsero gran parte del mondo scientifico.
Un giudizio particolarmente importante fu quello, che riportiamo di seguito integralmente, di due grandi pediatri, Rocco Jemma allora direttore della clinica pediatrica di Palermo, e in seguito di Napoli, e Giovanni di Cristina che in seguito divenne direttore della clinica pediatrica palermitana e che, insieme a Giuseppe Caronia, nel 1914 scoprì la fondamentale cura della malattia:
Se tutti dobbiamo riconoscere ch'è merito del Pianese di avere, colle sue geniali e pazienti ricerche, distaccato dal confuso capitolo delle anemie spleniche, quella dovuta al parassita di Leishman, non possiamo d'altra parte trascurare che si deve principalmente all'impulso fecondo dato dal Gabbi se lo studio di questa forma morbosa in Italia ha fatto progressi notevoli nel volgere di appena due anni.
/ (Jemma R., Di Cristina G. Sull'anemia da Leishmania nei bambini. Annali di Clinica Medica Anno 1 , fasc III, 30 dicembre 1910, pp. 544 - 545)
Oggi, esami eseguiti con sofisticate metodiche di elettroforesi, hanno dimostrato che all'interno del genere Leishmania ci sono tantissime specie diverse, per esempio infantum o donovani, tutte in grado di provocare la leishmaniosi. Aveva perfettamente ragione Gabbi.
Il terremoto del 1908 allontanò Gabbi da Messina. La nuova clinica fu distrutta dal sisma, durante il quale Gabbi perse una figlia. Nonostante la tragedia familiare si impegnò nel recare soccorso ai feriti e ai bisognosi, tanto che gli fu conferita la medaglia d'argento per la sanità pubblica.
Gabbi, rimasto privo di sede, fu allora chiamato nell'Università di Roma. Nel 1918. assunse la direzione della clinica medica dell'Università di Parma, ma negli anni successivi affiancò all'attività accademica e clinica, l'impegno politico: nel 1924 fu eletto deputato al Parlamento; nel 1929 fu nominato senatore del Regno.
Chiudi
|
Stampa La pagina di stampa crea anche un file immagine
Abstract Dominique De Vivo, Giuseppe Scimone, Renato Colomban, Margherita Serruto, Donatella Scimone, Guglielmo Catalioto
UO Pediatria Azienda Ospedaliera Papardo (ME)
La Sindrome dell’Arteria Mesenterica Superiore (SMA) INTRODUZIONE ED EPIDEMIOLOGIA
La Sindrome dell’Arteria Mesenterica Superiore (SMA) o Sindrome del Compasso Aorto-Mesenterico è molto rara. Ha una maggiore incidenza nel sesso femminile e presenta un picco di incidenza fra i 10 e 30 anni nel 75% dei casi. La patogenesi è ancora controversa. La Sindrome dell’arteria mesenterica è una condizione patologica in cui il duodeno viene compresso tra l’aorta addominale e l’arteria mesenterica. Normalmente l’angolo aorto-mesenterico è di circa 38°-56° con una distanza di 10-20 mm tra le 2 arterie. Nella Sindrome dell’arteria mesenterica superiore l’angolo diventa di 6°-25° e la distanza di 2-8 mm, con conseguente compressione della III porzione del duodeno. Il quadro clinico si caratterizza per la comparsa di un corteo sintomatologico che include angina addominale, nausea, vomito, anoressia, perdita di peso.
Tali sintomi sono comuni anche ad un’altra condizione patologica nota come Sindrome di Dunbar o Sindrome del Legamento Arcuato, in cui si ha la compressione del tratto prossimale del tronco
celiaco da parte del legamento mediano arcuato. Si tratta di una malattia rara, ha un’incidenza di 2 su 100.000 con un picco fin giovani donne tra i 30 e i 50 anni. La maggiore prevalenza è nel sesso femminile con un rapporto di 4:1. Il momento fisiopatologico si individua in una variante anatomica dell’origine del tripode celiaco. Il tronco celiaco durante la respirazione tranquilla e nella inspirazione profonda forma con l’asse dell’aorta un angolo acuto; nell’espirazione forzata viene compresso e stirato cranialmente dal legamento, con conseguente modifica dell’angolo da acuto ad ottuso. Questa variazione dell’angolo determina una stenosi emodinamicamente significativa con ischemia splancnica.
CASO CLINICO
Nell’Aprile 2024 è giunto alla nostra osservazione Ranith, un ragazzino di 10 anni per riferito vomito e febbre da circa una settimana. All’anamnesi patologica remota i genitori non hanno riferito nulla di rilevante da segnalare. Prima di giungere al nostro presidio ospedaliero, il bambino ha effettuato altri due accessi presso il Pronto Soccorso Pediatrico di un altro presidio ospedaliero dove è stato somministrato ondansetron endovena e reidratazione, solo con temporaneo
beneficio. Per la persistenza della sintomatologia, caratterizzata da numerosi episodi di vomito (5-7/die), alvo diarroico (3-5 evacuazioni/die) e febbre (TC max 39.5°C) è afferito al Pronto Soccorso Generale del nostro presidio e quindi ricoverato c/o la nostra UOC di Pediatria.
All’ingresso in reparto le condizioni generali erano scadute. Il ragazzino aveva un aspetto sofferente, presentava difficoltà alla deambulazione autonoma. La cute di colore secondo etnia, era secca e modicamente disidratata, le labbra asciutte e fissurate, lingua impaniata con lieve iperemia dei pilastri tonsillari. L’obiettività toracica era negativa; a carico del distretto addominale si evidenziava una dolenzia diffusa più accentuata alla palpazione profonda in corrispondenza del fianco sinistro, sebbene l’addome risultasse trattabile su tutti i quadranti. Non veniva riferita dai genitori contrazione della diuresi. Veniva pertanto reperito accesso venoso periferico e reidratazione endovenosa con NaCl 0.9% ed eseguiti esami ematochimici che mostravano un incremento di LDH (7 x N) e degli enzimi epatici, indici di flogosi negativi; all’emocromo si evidenziava una lieve leucopenia (GB 3930 /uL) con formula in equilibrio, ai limiti la conta piastrinica che era 120.000/ uL, nella norma la contra eritrocitaria. Veniva ripetuto a distanza di due giorni il prelievo ematochimico, con ulteriore riduzione dei leucociti (GB 2600 /uL), ulteriore incremento degli indici epatici ed incremento del CPK (10 x N), nella norma mioglobina ed esame urine; contestualmente veniva eseguita sierologia virale, film array nasale e gastroenterico, autoimmunità. Le condizioni cliniche del piccolo paziente rimanevano piuttosto scadute, persistevano gli episodi di vomito, nonostante il digiuno da oltre 5 giorni, iperpiressia (durante i primi due giorni di degenza), scarse evacuazioni liquide. Per la comparsa di addominalgia è stata eseguita in prima battuta ecografia addome che mostrava:«…dilatazione gastrica con presenza di liquidi e materiale alimentare nel lume gastrico..», e successivo esame radiologico a vuoto in ortostatismo: «Non livelli idroaerei né
aria libera. Evidente bolla gastrica». Per la persistenza della sintomatologia è stato deciso di eseguire TC addome completo con mezzo di contrasto che evidenziava: “...stenosi severa all’origine del tronco celiaco presumibilmente sostenuta da interferenza con i pilastri diaframmatici… ectasia del lume duodenale sino al tratto medio della sua porzione orizzontale, posta nello spazio compreso tra aorta e profilo posteriore dell’arteria mesenterica superiore avente dimensioni pari a 5 mm circa”. Gli esami eseguiti ci hanno permesso di porre diagnosi concomitante di Sindrome dell’arteria mesenterica superiore e Sindrome di Dunbar, Nei giorni successivi si è assistito ad un miglioramento delle condizioni cliniche del bambino, con risoluzione del vomito, e normalizzazione dei parametri bioumorali. E’stata riavviata una graduale rialimentazione con risoluzione della sintomatologia. E’stata infine eseguito esame gastroscopico al fine di escludere una stenosi critica da parte dell’arteria mesenterica superiore.
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Questo caso è apparso particolarmente interessante perché è esordito come una banale gastroenterite, che in realtà celava due quadri patologici misconosciuti molto rari che sono la Sindrome dell’arteria mesenterica superiore e la Sindrome di Dunbar. Nel nostro caso clinico infatti, il trigger virale ha innescato sia la miosite (con rialzo degli enzimi muscolari, mialgie diffuse e difficoltà alla deambulazione autonoma), sia la gastroenterite (con maggiore preponderanza del vomito nonostante il digiuno prolungato). E’stato proprio il persistere del vomito nonostante il digiuno prolungato, a indirizzarci all’esecuzione di esami radiologici di approfondimento.
La sindrome dell'arteria mesenterica superiore è un raro disordine dell'apparato gastrointestinale caratterizzato dalla compressione della terza porzione del duodeno da parte dell'aorta addominale (AA) e dell'arteria mesenterica superiore (SMA). Normalmente, il tessuto adiposo retroperitoneale si interpone nell'angolo superiore compreso tra il margine superiore del duodeno e la superficie inferiore dell'arteria mesenterica superiore. La sindrome della SMA interviene quando si verificano eventi che alterano questo tessuto, portando ad un anomalo restringimento dell'angolo arterioso in cui risiede la terza porzione duodenale. Condizioni di rischio sono rappresentati dall'inserzione alta del legamento di Treitz, dall'origine bassa dell'arteria mesenterica superiore o da una malrotazione intestinale intorto all'arteria. Al di là di queste condizioni predisponenti, si associano ad un aumento del rischio le seguenti alterazioni:
-Neoplasie retroperitoneali
-Sindromi da malassorbimento
-Cachessia
-Anoressia nervosa
-Lordosi lombare patologica
-Visceroptosi
-Lassità della parete addominale
-Adesioni peritoneali
-Rapido accrescimento in senso longitudinale durante la pubertà
-Importanti perdite di peso
-Nefrectomia sinistra
-Lesioni del midollo spinale
-Chirurgia della scoliosi
-Motilità compromessa del tratto gastrointestinale
Le manifestazioni tipiche sono:
-Sazietà precoce
-Vomito (che può essere anche biliare)
-Dispepsia post-prandiale
-Eruttazioni
-Cachessia
La Sindrome da compressione dell'arteria celiaca caratterizzata da dolore addominale ricorrente causato dalla compressione del tronco celiaco, è anche conosciuta come Sindrome di Dunbar, Sindrome del legamento arcuato mediano, Sindrome dell'asse celiaco. Anch’essa è una condizione rara, con un’incidenza di 2 su 100.000 persone, è più comune in giovani donne tra i 30 e i 50 anni
rapporto femmine/maschi di 4:1; è stata segnalata anche nei bambini. L’eziopatogenesi sembra essere legata alla compressione del tronco celiaco dovuta a due situazioni anatomiche possibili:
1)origine anormalmente alta del tronco celiaco
2)inserzione anormalmente bassa del diaframma
Un’altra ipotesi eziopatogenetica è quella di un’ischemia mesenterica intermittente. Le manifestazioni cliniche comprendono:
-dolore addominale epigastrico tipico esacerbato dall'espirazione
-dolore post-prandiale
-anoressia
-perdita di peso nel tempo
-diarrea
-possibile nausea e vomito
La Sindrome dell’Arteria mesenterica superiore e la Sindrome di Dunbar sono dunque due entità molto rare, la cui patogenesi è ancora controversa. La loro associazione è stata documentata in letteratura. In uno studio pubblicato nel 2001 infatti, sono stati reclutati retrospettivamente 57 pazienti con Sindrome di Dunbar e 27 pazienti con Sindrome dell’arteria mesenterica superiore; da questo studio è emerso che entrambe le sindromi erano presenti in sei dei pazienti reclutati. I pazienti sono poi stati sottoposti con successo a bypass duodeno-digiunale e decompressione dell’arteria celiaca.
Dunque il nostro caso clinico ci insegna che la Sindrome dell’arteria mesenterica superiore e la Sindrome di Dunbar sono due condizioni rare che possono essere associate. Il corteo sintomatologico, è rappresentato da: angina addominale, nausea, vomito, anoressia, perdita di peso. Il trattamento risolutivo è quello chirurgico.
Bibliografia
1)J Ultrasound2020 Jan 10;24(3):317–321. doi: 10.1007/s40477-019-00422-0 -Insight into Dunbar syndrome: color-Doppler ultrasound findings and literature review.
Ciro Acampora , Marco Di Serafino, Francesca Iacobellis, Piero Trovato, Luigi Barbuto , Nicola Sangiuliano , Luciana Costigliola , Luigia Romano
2)ECR 2013 / C-1800- DOI:10.1594/ecr2013/C-1800- The aorto-mesenteric angle and its elements: clinical and imaging features of vascular and gastrointestinal compression syndromes.
M. A. Lalanne, J. A. Ocantos, J. R. Coronil, E. Gentile, M. I. Cabrera, M. E. Sinclair , A. C. Seehaus, R. D. García-Mónaco; Buenos Aires/AR
3)Dunbar JD, Molnar W, Beman FF, Marable SA. Compression of celiac trunkand abdominal angina. Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med. 1965;95:731–744. doi: 10.2214/ajr.95.3.731.
4)Harjola PT. A rare obstruction of the coeliac artery; report of case. Ann Chir Gynecol Fenn. 1963;52:547–550.
5)Kim EN, Lamb K, Relles D, Moudgill N, Di Muzio PJ, Eisenberg JA. Median arcuate ligament syndrome-review of this rare disease. JAMA Surg. 2016;151(5):471–477. doi: 10.1001/jamasurg.2016.0002
6)Sunkara T, Caughey ME, Zhen KC, Chiong B, Gaduputi V. Dunbar syndrome-A rare cause of foregut ischemia. J Clin Diagn Res. 2017;11(7):OD13–OD14. doi: 10.7860/jcdr/2017/28142.10267)
7)Gander S, Mulder DJ, Jones S, Ricketts JD, Soboleski DA, Justinich CJ. Recurrent abdominal pain and weight loss in an adolescent: celiac arterycompression syndrome. Can J Gastroenterol. 2010;24:91–93. doi: 10.1155/2010/534654
8)Ozel A, Toksoy G, Ozdogan O, et al. Ultrasonographic diagnosis of median arcuate ligament syndrome: a report of two cases. Med Ultrason. 2012;14:154–157
Chiudi
|
Stampa La pagina di stampa crea anche un file immagine
Abstract Cutrupi Maria Concetta, Piraino Basilia, Astorino Maria Francesca, La Rosa Maria Angela, Briuglia Silvana, Esposito Emanuela
UOSD di Genetica e Farmacogenetica, Policlinico Universitario G Martino Messina
Malformazioni capillare - artero-venosa (CM-AVM): descrizione di un caso clinico Descriviamo il caso di una bambina di 7 anni giunta alla nostra osservazione per la presenza di una malformazione capillare dell'emi-volto, del tronco e degli arti; l'anamnesi familiare non era contributiva.
Secondogenita di genitori non consanguinei con gentilizio negativo per disabilità intellettiva o altre patologie degne di nota.
Nata da gravidanza normodecorsa esitata in parto eutocico. PN 2.750 Kg e fenomeni neonatali nella norma.
Dopo 2-3 mesi dalla nascita comparsa di malformazione capillare dell'emi-volto sx. Successiva visita dermatologica, all'età di 1 anno, che pone diagnosi di angioma.
Eseguite inoltre visita ECG e visita oculistica nella norma. Eseguiva inoltre valutazione neuropsichiatrica e d EEG risultati nella norma.
Nel sospetto di anomalie non specificate del sistema circolatorio giungeva alla nostra osservazione.
All'esame fenotipico caratteri familiari, chiazze teleangectasiche rosso violacee sull'emi-volto sinistro e sulla regione frontale destra, analoghe chiazze teleangectasiche circondate da alone anemico sul tronco e arti.
L'analisi di un pannello di geni responsabili di malformazioni vascolari ha rilevato la variante c.2484+1G>A in eterozigosi nel gene EPHB4 localizzato sul cromosoma 7q22.1, (Figura 1-2) che si localizza in un sito canonico di splicing. La variante di splicing ha una frequenza allelica pari a 0.000004004 nella popolazione generale (gnomAD), è riportata in letteratura scientifica associata con l'indicazione clinica (Ref. PMID: 28687708), è annotata nel database ClinVar (ID: 590874) e può essere classificata secondo le linee guida ACMG come variante patogenetica (classe 5).
Mutazioni patogenetiche del gene EPHB4 sono responsabili della sindrome da malformazione capillare-malformazione artero-venosa (CM-AVM) caratterizzata dalla presenza di molteplici piccole malformazioni capillari (1-2 cm di diametro) localizzate principalmente sul viso e sugli arti. Alcuni individui affetti presentano anche malformazioni artero-venose (AVM) e/o fistole artero-venose (AFV), anomalie vascolari a flusso rapido che in genere si presentano nella pelle, nei muscoli, nelle ossa, nella colonna vertebrale e nel cervello; le complicazioni potenzialmente letali delle MAV/FAV intracraniche possono includere sanguinamento, e conseguenze neurologiche quali convulsioni, idrocefalo, emicrania e insufficienza cardiaca. I sintomi delle AVM/FAV intracraniche sembrano manifestarsi precocemente nella vita. Diversi pazienti possono presentare la sindrome di Parkes-Weber (molteplici micro-FAV associate a una macchia capillare cutanea e a una crescita eccessiva dei tessuti molli e dello scheletro di un arto affetto). L'epistassi e le telengectasie tipicamente localizzate su labbra, tronchi e/o braccia/gambe sono state segnalate in individui con sindrome EPHB4, cosi come macchie bianche sulla pelle circondate da un alone pallido di eritema (macchie di Bier).
La crescita eccessiva degli arti è stata segnalata sia negli arti superiori che inferiori in individui con sindrome CM-AVM. La crescita eccessiva è in genere evidente nell'infanzia e può variare in gravità. La maggior parte degli individui con crescita eccessiva degli arti soddisfa i risultati della sindrome di Parkes Weber, definita da Revencu et al [2013b] come la presenza di una macchia capillare, iperplasia ossea e dei tessuti molli e molteplici microfistole arteriolovenulari in un arto superiore o inferiore.
Sono state segnalate malformazioni linfatiche in diversi individui con sindrome EPHB4. Segnaliamo che mutazioni patogenetiche del gene EPHB4 causano anche una rara condizione Lymphatic Malformation 7; LMPHM7 (OMIM 617300) caratterizzata da linfedema primario con fenotipo linfatico molto variabile che va da una grave idrope fetale linfatica, che può causare la morte perinatale o risolversi completamente fino a diventare del tutto asintomatica, a una presentazione lieve in pazienti anziani con vene varicose persistenti, edema periferico e alterato drenaggio linfatico negli arti inferiori. Il difetto del setto atriale è stato descritto in associazione e può essere l'unica anomalia in alcuni pazienti.
Per stabilire l'entità della malattia e le esigenze di un individuo a cui è stata diagnosticata la sindrome da malformazione capillare-malformazione arterovenosa (CM-AVM), si raccomandano le seguenti valutazioni: neurologiche con
imaging cerebrale, per identificare MAV/FAV (ad esempio, aneurismi della vena di Galeno e altre MAV intracraniche) e consentire l'identificazione precoce di macrofistole che possono essere trattate prima dello sviluppo dei sintomi,
imaging della colonna vertebrale per identificare e caratterizzare AVM/FAV da discutere con il radiologo, valutazione cardiologica, dermatologica e otorinolaringoiatrica per le epistassi e secondo necessità.
La penetranza della sindrome EPHB4 -CM-AVM è stata riportata essere del 93%.
La sindrome CM-AVM è ereditata in modo autosomico dominante. Ogni figlio di un individuo con sindrome CM-AVM ha una probabilità del 50% di ereditare la variante patogena. Sono possibili test genetici prenatali e preimpianto È stata descritta una significativa variabilità intra- e interfamiliare nell'esistenza e nella localizzazione delle malformazioni vascolari.
Figura 1-2 (GeneCards®: The Human Gene Database)
Figura 2: Struttura proteica del gene EPHB4 (Ephrin type-B receptor 4, GeneCards®: The Human Gene Database)
BIBLIOGRAFIA
1. Durrington HJ, Firth HV, Patient C, Belham M, Jayne D, Burrows N, Morrell NW, Chilvers ER. A novel RASA1 mutation causing capillary malformation-arteriovenous malformation (CM-AVM) presenting during pregnancy. Am J Med Genet A. 2013;161A:1690-4.
2. Eerola I, Boon LM, Mulliken JB, Burrows PE, Dompmartin A, Watanabe S, Vanwijck R, Vikkula M. Capillary malformation-arteriovenous malformation, a new clinical and genetic disorder caused by RASA1 mutations. Am J Hum Genet. 2003;73:1240-9. [PMC free article]
3. Grillner P, Soderman M, Holmin S, Rodesch G. A spectrum of intracranial vascular high-flow arteriovenous shunts in RASA1 mutations. Childs Nerv Syst. 2016;32:709-15
4. Hershkovitz D, Bercovich D, Sprecher E, Lapidot M. RASA1 mutations may cause hereditary capillary malformations without arteriovenous malformations. Br J Dermatol. 2008a;158:1035-40.
5. Hershkovitz D, Bergman R, Sprecher E. A novel mutation in RASA1 causes capillary malformation and limb enlargement. Arch Dermatol Res. 2008b;300:385-8.
6. Huang SJ, Amendola LM, Sternen DL. Variation among DNA banking consent forms: points for clinicians to bank on. J Community Genet. 2022;13:389-97.
7. Lapinski PE, Doosti A, Salato V, North P, Burrows PE, King PD. Somatic second hit mutation of RASA1 in vascular endothelial cells in capillary malformation-arteriovenous malformation. Eur J Med Genet. 2018;61:11-
8. Li, D., Wenger, T. L., Seiler, C., March, M. E., Gutierrez-Uzquiza, A., Kao, C., Bhoj, E., Tian, L., Rosenbach, M., Liu, Y., Robinson, N., Behr, M., and 12 others. Pathogenic variant in EPHB4 results in central conducting lymphatic anomaly. Hum. Molec. Genet. 27: 3233-3245, 2018.
9. Maruani A, Durieux-Verde M, Mazereeuw-Hautier J, Boccara O, Martin L, Chiaverini C, Eschard C, Bénéton N, Vabres P, Balguerie X, Plantin P, Bessis D, Barbarot S, Dadban A, Droitcourt C, Berthelot A, Lorette G, Leducq S, Samimi M, Andres C, Caille A, Vourc'h P, et al. Search for RASA1 variants in capillary malformations of the legs in 113 children: results from the French National Paediatric Cohort CONAPE. Acta Derm Venereol. 2018;98:251-5.
10. Mulliken JB, Young AE, eds. Vascular Birthmarks: Hemangiomas and Vascular Malformations. Philadelphia, PA: WB Saunders Co; 1988.
11. Oduber CE, van der Horst CM, Hennekam RC. Klippel-Trenaunay syndrome: diagnostic criteria and hypothesis on etiology. Ann Plast Surg. 2008;60:217-23.
12. Orme CM, Boyden LM, Choate KA, Antaya RJ, King BA. Capillary malformation--arteriovenous malformation syndrome: review of the literature, proposed diagnostic criteria, and recommendations for management. Pediatr Dermatol. 2013;30:409-15.
13. Overcash RT, Gibu CK, Jones MC, Ramos GA, Andreasen TS. Maternal and fetal capillary malformation-arteriovenous malformation (CM-AVM) due to a novel RASA1 mutation presenting with prenatal non-immune hydrops fetalis. Am J Med Genet A. 2015;167A:2440-3.
14. Rahbari R, Wuster A, Lindsay SJ, Hardwick RJ, Alexandrov LB, Turki SA, Dominiczak A, Morris A, Porteous D, Smith B, Stratton MR, Hurles ME, et al. Timing, rates and spectra of human germline mutation. Nat Genet. 2016;48:126-33.
15. Piffko A, Uhl C, Vajkoczy P, Czabanka M, Broggini T.EphrinB2-EphB4 Signaling in Neurooncological Disease. Int J Mol Sci. 2022 Jan 31;23(3):1679.
16. N Revencu 1,2, M Vikkula Cerebral cavernous malformation: new molecular and clinical insights J Med Genet. 2006 Mar 29;43(9):716-721.
17. Revencu N, Boon LM, Dompmartin A, Rieu P, Busch WL, Dubois J, Forzano F, van Hagen JM, Halbach S, Kuechler A, Lachmeijer AM, Lähde J, Russell L, Simola KO, Mulliken JB, Vikkula M. Germline mutations in RASA1 are not found in patients with Klippel-Trenaunay syndrome or capillary malformation with limb overgrowth. Mol Syndromol. 2013a;4:173-8.
18. Shirley MD, Tang H, Gallione CJ, Baugher JD, Frelin LP, Cohen B, North PE, Marchuk DA, Comi AM, Pevsner J. Sturge-Weber syndrome and port-wine stains caused by somatic mutation in GNAQ. N Engl J Med. 2013;368:1971-9.
19. Tan WH, Baris HN, Burrows PE, Robson CD, Alomari AI, Mulliken JB, Fishman SJ, Irons MB. The spectrum of vascular anomalies in patients with PTEN mutations: implications for diagnosis and management. J Med Genet. 2007;44:594-602.
20. Thiex R, Mulliken JB, Revencu N, Boon LM, Burrows PE, Cordisco M, Dwight Y, Smith ER, Vikkula M, Orbach DB. A novel association between RASA1 mutations and spinal arteriovenous anomalies. AJNR Am J Neuroradiol. 2010;31:775-9
21. Vivanti, A., Ozanne, A., Grondin, C., Saliou, G., Quevarec, L., Maurey, H., Aubourg, P., Benachi, A., Gut, M., Gut, I., Martinovic, J., Senat, M. C., Tawk, M., Melki, J. Loss of function mutations in EPHB4 are responsible for vein of Galen aneurysmal malformation. Brain 141: 979-988, 2018.
22. Yu, J.,Streicher, J. L., Medne, L., Krantz, I. D., Yan, A. C. EPHB4 mutation implicated in capillary malformation-arteriovenous malformation syndrome: a case report. Pediat. Derm. 34: e227-e230, 2017.
Chiudi
|
Stampa La pagina di stampa crea anche un file immagine
Case Report Laura Colavita1, Caterina Cuppari1
1UOC di Pronto Soccorso Pediatrico con OBI, Policlinico di Messina
Otomastoiditi acute in età pediatrica: nuove evidenze L'otomastoidite acuta è una infezione suppurativa delle celle mastoidee, collocate all'interno dell'osso mastoide. Suddetto processo infettivo è caratterizzato dalla presenza di materiale purulento nelle celle mastoidee (otomastoidite acuta con periostite). Nelle forme più severe i setti ossei che suddividono le celle mastoidee vengono erosi, configurando così il quadro di otomastoidite coalescente, che più facilmente si complica con formazione di ascessi, il più comune dei quali è l'ascesso subperiosteo.
Otiti medie acute sono presenti in anamnesi nel 40% dei casi, e nella metà dei pazienti sono state effettuate una o più terapie antibiotiche. Otiti medie acute appaiono pertanto essere la causa principale di otomastoidite. [1]
In una recente revisione sistematica della letteratura [2], in cui sono stati valutai 65 studi osservazionali con più di 2000 bambini nella casistica, la sintomatologia clinica più frequente di otomastoidite è rappresentata da malessere/letargia (96% dei casi); alterazioni otoscopiche della membrana timpanica (82% dei casi); alterazioni evidenti in sede retroauricolare (in corrispondenza dell'osso mastoideo) come eritema, dolore alla palpazione e/o tumefazione, quest'ultima generante dislocazione antero-laterale del padiglione auricolare (80% dei casi) (Fiigura 1); febbre (76% dei casi); edema con onseguente restringimento del canale uditivo esterno (71% dei casi); otalgia (67% dei casi) e otorrea (50% dei casi).
Figura 1.
Le complicanze, distinguibili in intra- ed etra-craniche, sono secondarie alla diffusione del processo infettivo alle strutture contigue, in una percentuale variabile a seconda dello studio preso in considerazione, tra il 15 e il 30% dei casi, con una prevalenza delle complicanze intra-craniche. Quest'ultime sono rappresentate da meningite, ascesso cerebrale (lobo temporale) o cerebellare, ascesso epidurale o subdurale e trombosi dei seni venosi. Le complicanze extra-craniche comprendono invece l'ascesso subperiosteso; la paralisi del VII° nervo cranico; la riduzione dell'udito secondaria all'otite media acuta associata (nella maggior parte dei casi transitoria; può divenire permanente qualora venissero danneggiati gli ossicini e/o la coclea); la labirintite; l'osteomielite e l'ascesso Bezold, quando il materiale purulento si và a localizzare in corrispondenza dei muscoli sternocleidomastoideo e digastrico. (Figura 2.) [1]
Figura 2.
In letteratura, l'incidenza in età pediatrica varia in base agli studi considerati: 1 su 400 pazienti con otite media acuta (0.24%) [3]; da 1.2 a 6.1 su 100.000 pazienti di età inferiore ai 14 anni, con una prevalenza nei primi 2 anni di vita [4].
Nell'ultimo anno abbiamo osservato un netto aumento di diagnosi di otomastoidite acuta, con differenze anche inerenti la fascia d'età prevalentemente interessata. Abbiamo pertanto voluto raccogliere dati numerici per quantizzare e caratterizzare meglio eventuali cambiamenti epidemiologici e/o clinici dell'otomastoidite acuta, valutando i pazienti pediatri che afferiscono all'U.O.C. di Pronto Soccorso Pediatrico con Osservazione Breve Intensiva del Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina. Da Gennaio 2024 a Maggio 2024 (08/05/2024) sono state diagnosticate 22 otomastotiditi acute su 4912 accessi (incidenza pari a 0.5%), con un prevalente interessamento dell'età scolare (6-9 anni d'età) (Figura 3.).
Figura 3.
Alla base di tale aumento d'incidenza di otomastoiditi acute in età pediatrica potrebbero giocare un ruolo più fattori, il cui peso singolarmente è in atto difficilmente quantizzabile.
L'aumento dell'antibiotico-resistenza, soprattutto dopo la pandemia COVID, costituisce sicuramente un fattore causale di rilievo. Tanto l'Istituto Francese Pasteur che i CDC (Centers for Disease Control and Prevention) americani concordano nell'evidenziare questo dato e nel sottolineare che, sebbene le infezioni batteriche in generale risultassero diminuite significativamente nel periodo del lockdown, terapie antibiotiche venissero ampiamente prescritte sia in pazienti SarsCoV2 positivi (per prevenire e/o trattare sovrapposizioni batteriche) che in pazienti SarsCoV2 negativi febbrili, soprattutto nell'impossibilità di effettuare tempestivamente una visita medica. In Italia, le terapie antibiotiche più frequentemente prescritte durante il lockdown in bambini febbrili (indipendentemente dalla positività per SarsCoV2) sono rappresentate da amoxicillina con o senza clavulanato, azitromicina, claritromicina e cefalosporine. Lo sviluppo di resistenza verso tali antibiotici può spiegare come più facilmente otiti medie acute trattate con le suddette molecole non si risolvano e si complichino pertanto più facilmente in otomasotidite acuta.
Altro fattore può essere di tipo immunologico. I bambini, soprattutto in epoca pre-scolare, vanno più facilmente incontro a infezioni respiratorie ricorrenti (IRR), soprattutto a carico delle alte vie aeree. Ciò è legato sia a fattori anatomici (ridotta pervietà delle vie respiratorie, ridotta clearance muco-ciliare, orizzontalizzazione delle tube di Eustachio che predispone a otiti) che immunologici, coinvolgenti tanto l'immunità innata (ridotta espressione dei Toll-Like-Receptors sulle cellule presentanti l'antigene- APC; immaturità quantitativa e funzionale dei neutrofili; ridotta produzione di lattoferrina, NO e fibronectina) quanto quella acquisita (ridotta attività di linfociti T e B; ridotta produzione di anticorpi). Nel determinismo delle IRR (tra cui anche di una maggiore facilità a otiti) vi sono inoltre l'immunodepressione post-infettiva (bambini andati di recente incontro a un processo infettivo acuto respiratorio vengono reintegrati all'asilo durante la fase di convalescenza, in cui il sistema immunitario è ancora “debilitato” e pertanto meno attivo nel suo ruolo di difesa) e la verginità immunologica, in virtù della quale il primo incontro con un determinato patogeno si traduce in malattia per l'assenza di memoria immunologica, che sarà invece attiva ed efficace nella difesa a un secondo incontro con lo stesso patogeno. Il lockdown legato al COVID ha sicuramente determinato il mancato sviluppo di memoria immunologica verso diversi patogeni che normalmente s'incontrano in epoca pre-scolare. Questo potrebbe in parte spiegare il motivo per cui l'età media in cui abbiamo attualmente osservato il maggior riscontro di otomastoiditi non è più quella pre-scolare (come descritto in letteratura) ma quella scolare.
Infine, il suddetto incremento di otomastoiditi acute potrebbe anche essere correlato a un aumento delle diagnosi radiologiche, in bambini senza i classici segni clinici.
La diagnosi di otomastoidite acuta non dovrebbe avvalersi dell'ausilio di esami radiologici in presenza dei classici segni clinici sopra descritti, ma si dovrebbe ricorrere a studio TAC nei casi sospetti paucisintomatici e/o per escludere complicanze. Esami TAC vengono invece sempre più ampiamene utilizzati non solo per la valutazione di casi sospetti di otomastoidite ma anche per lo studio di altri quadri clinici, quali ad esempio cefalee e traumi cranici. I criteri radiologici diagnostici per otomastoidite acuta si hanno nella forma coalescente, in cui i setti ossei delimitanti le celle mastoidee appaiono mal definiti o francamente erosi; in presenza di distruzione o irregolarità della corteccia dell'osso mastoide o infine in caso di riscontro di alterazioni del periostio (ispessimento, erosione o formazione di ascesso subperiosteo). Il semplice riscontro di perdita della normale pneumatizzazione delle celle mastoidee per presenza di materiale fluido non è diagnostico, come unico rilievo, di otomastoidite acuta e si rileva spesso in bambini con otite media acuta.
Infine la terapia dell'otomastoidite acuta si basa sull'utilizzo di terapia antibiotica sistemica e sul drenaggio dell'orecchio medio. Quest'ultimo, seppur non effettuato in diversi Centri, si rivela di particolare utilità anche al fine di individuare una terapia antibiotica mirata tramite l'esecuzione di esame colturale del materiale purulento prelevato con antibiogramma. In considerazione dei patogeni più frequentemente implicati (streptococcus pneumoniae e pyogenes, fusobacterium necrophorum, haemophilus influenzae, staphilococcus aureus e pseudomonas aeruginosa, quest'ultimo più tipico dei pazienti con infezioni ricorrenti dell'orecchio medio), la terapia antibiotica ev si basa sulla presenza all'anamnesi di otiti medie acute ricorrenti (OMA) e di recenti terapia antibiotiche eseguite. In pazienti con anamnesi silente per OMA ricorrenti e che non hanno recentemente effettuato terapie antibiotiche, la molecola di prima scelta è l'ampicillina-sulbactam . In pazienti invece con storia di OMA ricorrenti e/o recente terapia antibiotica (entro 6 mesi) è indicato l'uso di piperacillina-tazobactam. E' anche possibile ricorrere all'associazione di ceftazidima o cefepima con metronidazolo. In pazienti allergici ai bata-lattamici si consiglia invece l'associazione di vancomicina o linezolid con metronidazolo.
In presenza di una soddisfacente risposta clinica, soprattutto se disponibili gli esiti degli esami colturali, la terapia antibiotica dovrebbe essere effettuata per 7-10 giorni, proseguendo con terapia antibiotica per os per un totale di 4 settimane di trattamento.
In presenza di complicanze sarà necessario considerare l'approccio chirurgico (mastoidectomia, drenaggio dell'orecchio medio con tubo timpanostomico, drenaggio di eventuali ascessi).
Bibliografia
[1] Ellen R Wald, MD. Acute mastoiditis in children: Clinical features and diagnosis. UpToDate, May 2023
[2] Bertolaso C, Cammisa I, Orsini N, Sollazzo M, Sardaro V, Gatto A, et al. Diagnosing acute mastoiditis in a Pediatric Emergency Department: a retrospective review. Otol Neurotol. 2008;29(6):751
[3] S Quesnel, M Nguyen, S Pierrot, P Contencin, Y Manach, V Couloigner. Acute mastoiditis in children: a retrospective study of 188 patients. Int. J. Pediatr. Otolaryngol. 2010; 74: 1388-1392.
[4] Pasquale Cassano, Giorgio Ciprandi, Desiderio Passali. Acute mastoiditis in children. Acta Biomed 2020; Vol. 91, Supplement 1: 54-59
Chiudi
|
Stampa La pagina di stampa crea anche un file immagine
Case Report M. Parisi1, G. Cavo'2, G. Pino2, L. Rossano2, S. R. Abrami2, G. Pagano2
1Università degli studi di Messina
2U.O.C. Pronto soccorso pediatrico con OBI, AOU "G.Martino"
Effetti epigenetici del tocco dolce sui neonati prematuri Si stima che il 50% dei neonati critici sopravvissuti è ad alto rischio di morbilità e di grave compromissione per lo più polmonare e neurologica. Negli incontri di follow-up, infatti, i reperti di più facile riscontro sono deficit intellettivi, cognitivi-comportamentali, di elaborazione sensoriale (cecità, sordità), disturbi dello spettro autistico e paralisi cerebrale. Pertanto, diventano parte integrante dell’intero percorso assistenziale in UTIN le misure rivolte alla neuroprotezione, inquadrate nell’ambito delle cosiddette Cure dello Sviluppo (Developmental Care), da attuarsi in risposta ai bisogni individuali del neonato. Ad esse appartengono le strategie di neuroprotezione ed il tocco gentile, e si integrano al più ampio filone del metodo NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program) proposto dalla Dott.ssa H. Als tra il 1984-1986 che, riprendendo ed ampliando alla coorte dei prematuri gli studi sullo sviluppo infantile condotti dal pediatra Dr. T. Barry Brazelton, dimostrò che il pretermine non è un “neonato deficitario” ma un individuo competente, dal funzionamento appropriato per l’ambiente intrauterino ed inappropriato per l’ambiente extrauterino, sovraccarico di stimoli (luci, rumori, manipolazioni) che risulterebbero ovattati all’interno della cavità uterina, e capace persino di comunicare il suo stato di benessere e/o di disagio. La metodologia, che ancora oggi riscuote ampio consenso da parte di esperti e società scientifiche – tanto che in alcune realtà assistenziali sono previsti corsi di formazione ad hoc dedicati ai professionisti – prevede che dalla corretta interpretazione del comportamento, si possano definire ed attuare strategie assistenziali e di accudimento adeguate alle capacità del piccolo via via raggiunte ed emergenti, coniugando aspetti tecnico-scentifici con aspetti emozionali e relazionali.
Il tocco gentile o dolce sui neonati, purché dinamico, comporta numerosi benefici a breve e medio-lungo termine. Il tocco dinamico consiste in una stimolazione tattile pressoché identica alle carezze umane per le sue proprietà termomeccaniche:
- erogata ad una temperatura di 32°C (corrispondente con buona approssimazione alla temperatura esterna della cute),
- ad una velocità ideale di 3 cm/s
- ed una forza di circa 0,3 N “sufficiente a produrre una lieve rientranza nella pelle”.
Risultati migliori si ottengono sottoponendo i neonati a sessioni di tocco dinamico dopo averli posizionati sul fianco destro, due minuti prima del contatto e per tutta la sua durata, erogando la procedura touch dalla prima vertebra toracica all’ultima vertebra lombare, coprendo un’area di circa 10 cm, e in senso inverso, continuativamente per 5 minuti. Questo tipo di contatto caregiver-neonato è in grado di abbassare nell’immediato i livelli di stress e dolore, a differenza del tocco statico che non produce gli stessi esiti.
La riduzione del pianto e la diminuzione dei movimenti, sommati alla decelerazione della frequenza cardiaca, alla riduzione della pressione arteriosa e all’aumento della saturazione periferica di ossigeno, rilevate durante il contatto e mantenute nei 5 minuti post-touch, si interpretano come segni indicativi di rilassamento. A sessioni più frequenti di tocco dolce, inoltre, si associano un più rapido incremento di peso ed una riduzione dei giorni di degenza ospedaliera. Per tali ragioni, al tocco dolce è stato recentemente attribuito l’appellativo di ‘nutritivo’. Tali benefici possono essere ottimizzati, in relazione soprattutto all’aumento del peso, prevedendo l’attuazione di un programma assistenziale comprensivo di sessioni di tocco dolce della durata di 15 minuti, 3 volte al giorno per almeno 5 giorni, estendendo l’area di stimolazione ad altre zone del corpo, dalla testa agli arti.
Per quanto concerne la relazione fra il tocco dinamico e gli esiti a medio e lungo termine, gli studi sui programmi di follow-up hanno evidenziato migliori outcome neurocognitivi tra 12 e 24 mesi di età corretta: pare che la qualità del tocco influenzi la formazione dei legami di attaccamento, migliorando le capacità di apprendimento sociale ed intelligenza emotiva. Questo potrebbe essere spiegato da una scoperta recente secondo cui il tocco gentile è in grado di lasciare impronte sul DNA umano. Lo studio sulle interazioni precoci ha evidenziato l’importanza del contatto tattile per i risultati biocomportamentali attraverso una modifica nella metilazione del DNA (DNAm). Nello specifico, è stata indagata la correlazione tra il contatto precoce caregiver-neonato, le modifiche epigenetiche nei bambini esposti e non esposti al contatto 4-5 anni dopo e l’incidenza di condizioni di disagio infantile. Sono state identificate regioni metilate diversamente tra i gruppi di contatto alto e basso e i bambini che avevano ricevuto un minore contatto da parte degli operatori sanitari, mostravano condizioni di disagio infantile con maggiore frequenza. Tuttavia nessun sito di DNAm del gene candidato è stato associato in maniera univoca al contatto postnatale precoce.
La piacevolezza del tocco e la minore reattività agli stimoli dolorosi – quest’ultima mediata dalla sostanza P, la cui presenza è dimostrabile sin dall’8a settimana di età gestazionale e controbilanciata dagli inibitori della nocicezione, prodotti più tardivamente – e allo stress, derivano dal rilascio di ossitocina (OT) e oppioidi endogeni, in seguito alla stimolazione delle afferenze C-tattili, fibre nervose di recente identificazione, amieliniche, a bassa soglia di meccanorecettori, che si trovano nella cute non glabra e rispondono in maniera ottimale al tocco carezzevole a bassa forza e velocità, ovvero a quella tipologia di tocco che gli esseri umani percepiscono come più piacevole. E poiché la cute innervata dalle afferenze CT, è innervata anche da fibre mielinizzate, è proprio l’attivazione simultanea di entrambe le tipologie di fibra a determinare la percezione di un tocco piacevole, tanto per il ricevente quanto per il donatore.
Bibliografia e sitografia
- A.A. Fanaroff, J.A. Fanaroff, Cure del neonato ad alto rischio, 7a edizione, Antonio Delfino Editore, 2020, Roma
- J. Cascio et al., Social touch and human developement, Elsevier Ltd. Agosto 2020 https://doi.org/10.1016/j.dcn.2018.04.009
- Marie Auguirre et al., Infants discriminate the source of social touch at stroking speeds eliciting maximal firing rates in CT-fibers, marzo 2019 https://doi.org/10.1016/j.dcn.2019.100639
- Mazzotti et al., Dynamic touch reduces physiological arousal in preterm infants: A role for ctactile afferents?, agosto 2019 https://doi.org/10.1016/j.dcn.2019.100703
- Sarah R. Moore et al., Epigenetic correlates of neonatal contact in humans, novembre 2017, doi:10.1017/S0954579417001213
Chiudi
|
Stampa La pagina di stampa crea anche un file immagine
Case Report G .Cavò1, S.R. Abrami1, P. Lonia2, C. Crea3, H. Crasci3
1 U.O.C. Pronto soccorso pediatrico con OBI, AOU “G.Martino”
2 U.O.C. Pediatria AOU “G.Martino”
3 Università degli studi di Messina
Somministrazione intraossea nell’emergenze pediatriche L'infusione intraossea (IO) è una tecnica medica utilizzata per somministrare farmaci, liquidi e altre terapie direttamente all'interno del midollo osseo. Viene spesso impiegata in situazioni di emergenza, quando l'accesso venoso periferico risulta difficile o impossibile, come nei pazienti in shock, traumi gravi o arresto cardiaco. Il midollo osseo rappresenta un tessuto altamente vascolarizzato, permette quindi una rapida distribuzione dei farmaci nel sistema circolatorio, garantendo un'efficace risposta terapeutica.
Quando si utilizza l'infusione intraossea?
L'accesso intraosseo oggi è indispensabile nelle seguenti circostanze:
Emergenze pediatriche: nei bambini, le vene periferiche possono essere difficili da trovare, specialmente in situazioni di shock o disidratazione grave.
Adulti in arresto cardiaco: nei pazienti adulti in arresto o in situazioni critiche, l'accesso intraosseo può fornire un'alternativa rapida all'infusione endovenosa.
➢Traumi gravi: incidenti o traumi con perdita di sangue o ipotensione, il metodo IO assicura un’entrata efficace ai farmaci per il supporto vitale, evitando così un conseguente shock settico o ipovolemico.
Le linee guida dell’Emergency Cardiovascular Care del 2000 raccomandano l’accesso intraosseo per tutti i pazienti pediatrici che richiedono una rapida somministrazione di liquidi e farmaci, dopo due tentativi falliti di accesso venoso tradizionale o davanti a collasso cardiocircolatorio”.
Anatomia dell’osso
L’osso per le sue caratteristiche è una sede d’infusione di pari efficacia alla via venosa è utile per la sua rapidità di reperimento nel trattamento delle emergenze. Sappiamo che il midollo osseo rappresenta un tessuto altamente vascolarizzato strettamente connesso a numerosi canali midollari al sistema intravascolare.
La presenza della robusta trabecolatura, rende il midollo una vena “non collassabile” utile in situazioni di grave ipovolemia o schock.
Le stesse trabecole però determinano resistenza al flusso che va dal midollo al circolo sistemico, si rende necessario per questo motivo all’inizio dell’infusione una somministrazione di circa 10 ml a pressione positiva di soluzione isotonica per vincere tale resistenza evitando così che il flusso infusionale risulti basso.
Tecnica e punti di accesso
Per l'inserimento dell'ago intraosseo si utilizzano vari punti di accesso, soprattutto in base all'età. I più comuni sono:
➢Tibia prossimale: sopra la tibia, sotto la rotula; una delle aree più usate.
➢Sterno: spesso riservato a situazioni estreme o per adulti.
➢Omero prossimale: utile negli adulti, poiché consente una rapida infusione.
(l’immagine inserita appartiene alla Vidacare, produttrice del trapano da intraossea EZ-IO, che ne detiene i diritti d’autore.)
Tecnica di inserzione e precauzioni
La tecnica richiede competenza e preparazione, e comprende alcuni passaggi standard:
1.Identificazione della sede.
2.Pulizia e disinfezione del sito.
3.Inserimento dell’ago utilizzando un dispositivo automatico o manuale, mantenendo l'angolo appropriato.
4.Conferma dell'accesso attraverso il flusso libero di liquidi.
Individuato il punto d’inserzione si procede con una buona antisepsi; quando il paziente è cosciente va somministrato un anestetico locale con Lidocaina 1% (non obbligatoria, ma utile per inibire la percezione di dolore).
Dispositivi d’introduzione
I dispositivi nel tempo sono stati sempre migliorati per praticità e qualità. Li possiamo classificare in tre categorie:
1.Manuali: I dispositivi manuali sono simili ai cateteri venosi sono caratterizzati infatti da mandrino e cannula, questi dispositivi sono poco utilizzati perché poco pratici, richiedono particolare sforzo e abilità dell’operatore.
2.Semiautomatici: come i BIG (Bone Injection Gun), dotati di meccanismi a molla precaricato che permettono all’ago di penetrare nell’osso questi dispositivi trovano ampio utilizzo in contesti militari per la sede sternale.
3.Meccanici: trattasi di un vero e proprio trapano riutilizzabile più volte alimentato a batteria; si sceglie l’ago di dimensioni adatte al tipo di paziente, l’ago viene inserito nella parte terminale del trapano, si aziona e in pochissimo tempo l’ago supera la resistenza dell’osso e penetra nel tessuto sottostante.
Per l'inserimento, si utilizzano aghi specifici che perforano l’osso e raggiungono il midollo osseo, creando un canale di accesso per l'infusione. Gli aghi utilizzati sono cavi, con un diametro che permette l’infusione veloce e adatti alla pressione intraossea.
Dopo il reperimento dell’accesso è consigliato una somministrazione di soluzione isotonica per liberare il lume da eventuali frammenti ossei che ostruirebbero il lume dell’accesso stesso che deve rimanere pervio.
Successivamente si possono somministrare farmaci o soluzioni ritenute utili che normalmente somministriamo per via endovenosa, consapevoli del fatto che i tempi di raggiungimento della concentrazione plasmatica saranno invariati.
La velocità del flusso è comunque influenzata dalla sede d’inserzione; si considera mediamente circa 80 ml/min, che può superare i 120 ml/min se si utilizza una sacca a pressione positiva.
Vantaggi e svantaggi
L’infusione intraossea presenta diversi vantaggi, tra cui:
➢Rapidità e affidabilità: può essere effettuata in pochi secondi, permettendo una rapida somministrazione dei farmaci.
➢Accesso stabile: garantisce un accesso sicuro, con un minor rischio di fallimento rispetto all'accesso venoso tradizionale, soprattutto nei pazienti instabili.
Tuttavia, presenta anche alcuni svantaggi e possibili complicazioni, come:
➢Osteomielite: un'infezione del midollo osseo che può insorgere se non si seguono rigorosi protocolli igienici.
Necrosi tissutale e sindrome compartimentale: legate a una somministrazione non corretta o prolungata.
Dolore: il processo può essere doloroso, soprattutto per il paziente cosciente.
Conclusioni
L'infusione intraossea è uno strumento prezioso in emergenza e terapia intensiva, con un potenziale salvavita elevato. La formazione del personale sanitario è cruciale per garantire un corretto utilizzo. Nonostante i rischi connessi questa pratica in situazioni di criticità rappresenta un'opzione efficace.
Prospettive future e ricerca
Le tecnologie per l'infusione intraossea sono in evoluzione, con nuovi dispositivi che migliorano la sicurezza e riducono le complicanze. La ricerca è incentrata sull'identificazione di materiali migliori per gli aghi e su metodiche che riducano ulteriormente i tempi di accesso.
➢Studi sull'efficacia e la velocità dell'accesso intraosseo: Numerosi studi dimostrano che l'accesso intraosseo viene reperito più rapidamente rispetto all'accesso venoso periferico, specialmente in pazienti pediatrici, politraumatizzati o in stato di shock. La somministrazione di fluidi e farmaci tramite accesso IO ha un tasso di assorbimento simile a quello endovenoso.
➢Linee guida internazionali per il trattamento avanzato: Il supporto avanzato per la vita (ACLS) dell'American Heart Association (AHA) raccomanda l'intraossea come alternativa valida all'accesso venoso nelle emergenze mediche. Secondo le linee guida, l'accesso IO è sicuro ed efficace per la somministrazione di liquidi, farmaci e anche per il prelievo di campioni ematici per le analisi di laboratorio.
➢Rischi e complicanze: Le complicanze dell'infusione IO sono rare ma includono infezioni locali, embolia grassa, sindrome compartimentale e danno osseo. Studi sulla sicurezza evidenziano che, se correttamente posizionata, la cannula IO riduce significativamente il rischio di complicazioni rispetto a metodi di accesso più invasivi.
➢Uso in pediatria e geriatria: In pediatria, l'accesso IO è particolarmente vantaggioso in situazioni di emergenza, dove l'accesso venoso può essere più difficile. Negli adulti anziani e in pazienti con patologie croniche che compromettono le vene, l'accesso intraosseo può essere un'opzione altrettanto efficace e sicura.
➢Studi comparativi con altri metodi di accesso: La letteratura scientifica riporta che l'accesso IO risulta spesso preferibile nelle situazioni di emergenza rispetto ai cateteri venosi centrali, poiché richiede meno tempo per l'inserimento e comporta un rischio inferiore di complicanze legate alla procedura.
Bibliografia e sitografia
• https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30893227/
• https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32242841/
• https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37391199/
• https://infermieripreh.wordpress.com/2015/08/04/la-via-di-infusione-intraossea/
• https://nursetimes.org/accesso-intraosseo-indicazioni-controindicazioni-procedure-e-sedi-dinserzione...#
•Pillole di emergenza- www.simeup.com
•Philbeck T., Miller L., Montez D. et al. (2010). "Clinical review of intraosseous access in prehospital and hospital-based emergency care.” American Journal of Emergency Medicine.
•Hallas P., Brabrand M., Folkestad L. (2012). "Complication with intraosseous access: an observational study of 30,000 intraosseous insertions." Resuscitation.
•Schalk R., Byhahn C., Fieguth H., et al. (2009). "Bone marrow puncture for infusion in emergency situations: technique, indications, and complications." Anaesthesist.
•Guyette FX., Bieshke K., McCarthy J., et al. (2005). "Success and safety of intraosseous access in an urban prehospital setting." Prehospital Emergency Care.
Chiudi
|
Crea la webApp di questo sito facendo click sul pulsante
"Aggiungi a schermata Home"
che trovi nel menu del browser di qualsiasi cellulare o tablet
|
|
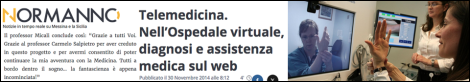




 L’estratto di ribes nigrum contiene numerosi principi attivi, tra cui flavonoidi edantocianosine, che esercitanobenefiche attività antivirali ed antibatteriche, anti-infiammatorie,muco-attive e vaso-protettive, (fig.3). In particolare la documentata attività antiinfiammatoria, per certi aspetti similcortisonica, potrebbe avere un naturale beneficio nel ridurre l’infiammazione acuta e, ancora, nel contrastare la flogosi allergica minima persistente” dei soggetti allergici.
L’estratto di ribes nigrum contiene numerosi principi attivi, tra cui flavonoidi edantocianosine, che esercitanobenefiche attività antivirali ed antibatteriche, anti-infiammatorie,muco-attive e vaso-protettive, (fig.3). In particolare la documentata attività antiinfiammatoria, per certi aspetti similcortisonica, potrebbe avere un naturale beneficio nel ridurre l’infiammazione acuta e, ancora, nel contrastare la flogosi allergica minima persistente” dei soggetti allergici.







